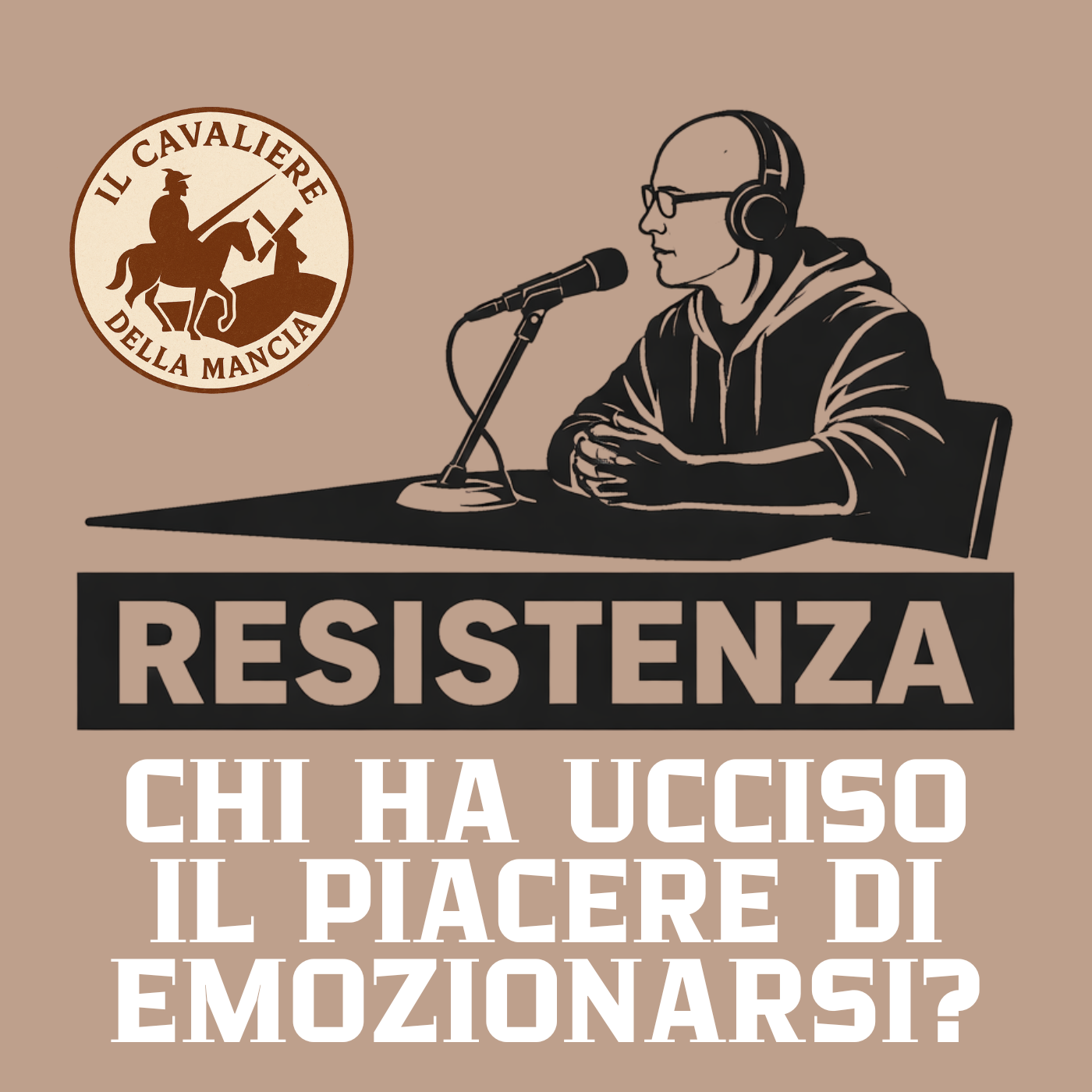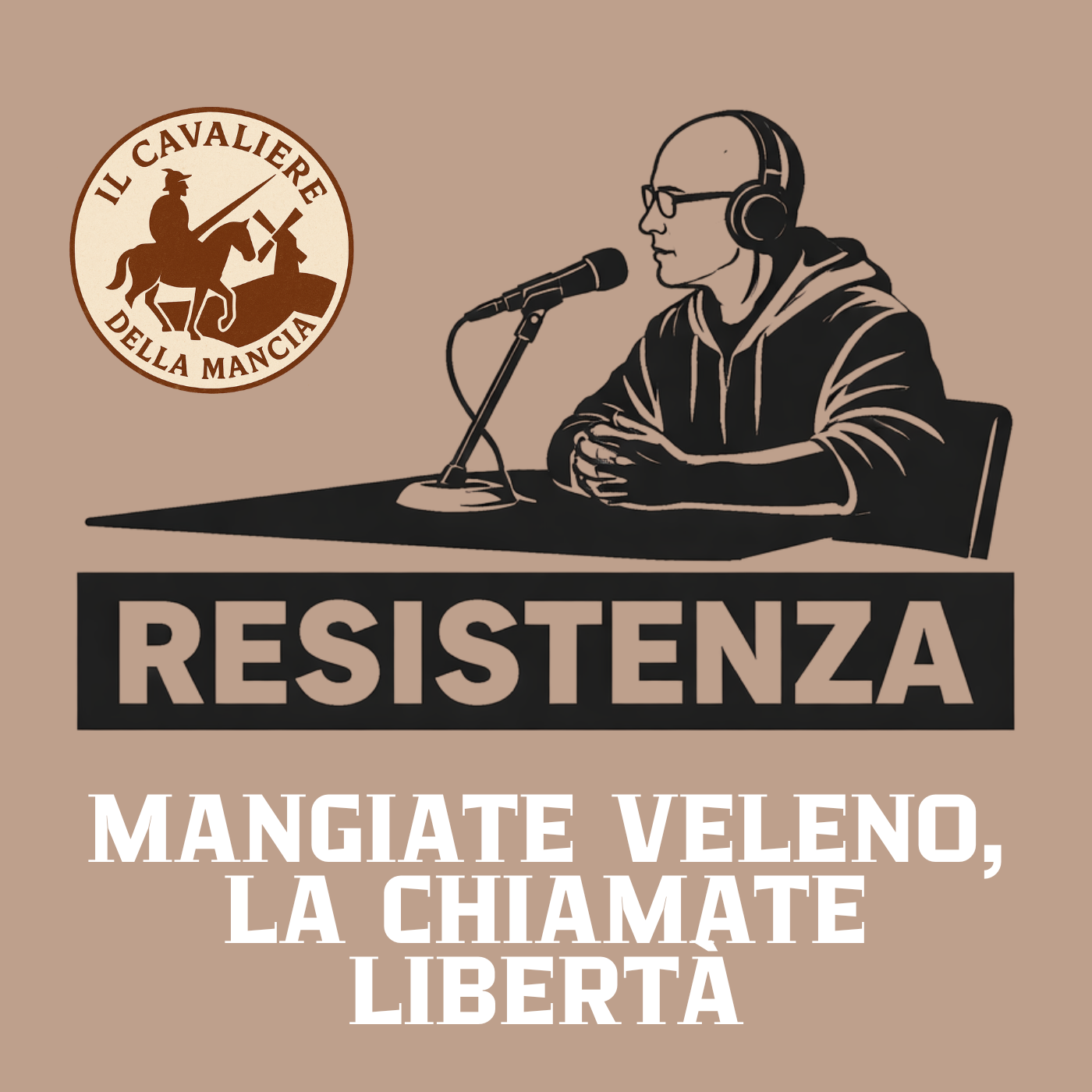Berlino, 1926.
Le strade della capitale sono fitte di tram, di biciclette cigolanti, di venditori ambulanti con gli occhi stanchi. Ma sopra ogni cosa… silenzio. È il silenzio di chi non osa più desiderare.
La Germania è uscita a pezzi dalla Prima Guerra Mondiale. L'umiliazione del Trattato di Versailles grava come una pietra tombale sulle spalle di una nazione intera. E poi… la spirale dell'iperinflazione.
La moneta perde valore così in fretta che un caffè costa più alla fine della tazzina che all'inizio. I bambini giocano con mattoni di banconote svalutate. Le famiglie bruciano i marchi per scaldarsi, perché costano meno della legna.
Ma c'è un dettaglio che i libri di storia raccontano a mezza voce: migliaia di cittadini tedeschi portarono i loro cani ad essere soppressi. Non per crudeltà. Non per disamore. Ma perché lo Stato aveva introdotto — o meglio, inasprito — una tassa sul possesso di animali domestici. Una tassa che trasformava l'affetto in privilegio.
È il momento in cui la povertà entra nel cuore. Non si limita a svuotare le dispense. Inizia ariscrivere i confini dell'amore. Inizia a dire: puoi amare, ma solo se puoi permettertelo.
E così, a Berlino, file silenziose davanti ai rifugi. Padroni che accompagnano i loro cani per l'ultima volta. Occhi lucidi, mani tremanti. Alcuni lasciano i loro animali davanti alle porte dei rifugi, come neonati abbandonati. Altri assistono in silenzio all'ultima iniezione.
Nessuno protesta. Nessuno scende in piazza. L'amore si spegne, in silenzio.
Ma cosa succede quando un popolo impara che tutto ha un prezzo, anche l'affetto? Quando perfino un abbaio diventa una colpa, un lusso da eliminare?
Succede che si crea una frattura morale, invisibile e irreparabile. Succede che si inizia a pensare in termini di "utile" e "inutile". E l'inutile viene eliminato. È il terreno perfetto per ciò che verrà pochi anni dopo. Perché quando impari a rinunciare al cane, poi rinuncerai anche al vicino di casa, al diverso, all'anziano, all'invalido.
Quando l'empatia viene tassata, il cinismo diventa legge.
E questa ferita… la Germania se la porta ancora addosso. Ancora oggi, il trauma dell'iperinflazione del '23-'24 è inciso nella psiche collettiva tedesca. È per questo che la Bundesbank è ossessionata dalla stabilità dei prezzi. È per questo che ogni tedesco sopra i 60 anni, se gli chiedi "che cos'è l'inflazione?", non ti parla di economia, ma di vergogna, di pane mancato, di cani scomparsi.
Ma torniamo a noi.
Oggi non ci chiedono più di sopprimere i cani. No.
Oggi ci chiedono di scegliere tra il tempo con i nostri cari e un lavoro che ci dissangua. Ci chiedono di sacrificare l'infanzia dei nostri figli per pagare un mutuo. Di mettere in una casa di riposo i nostri genitori, perché dobbiamo fare straordinari per permetterci… quella stessa casa. A Roma, Milano, Londra, Monaco, Parigi: un tetto sopra la testa vale quanto tre vite intere. Due stipendi, due esaurimenti nervosi, tre babysitter e zero tempo. E no, non è perché le cose costano di più. È perché i ricchi sono sempre più schifosamente ricchi.
Perché ci hanno fatto credere che dobbiamo lavorare di più per avere quello che i nostri nonni avevano con un solo stipendio e una sola domenica libera.
Perché l'economia non è in crisi: è la giustizia sociale a essere morta.
Ricordare Berlino 1926 non è un esercizio di nostalgia. È un atto di resistenza. È ricordare che ogni epoca ha il suo modo di tassare l'amore. Allora fu un bollettino sulle spalle di un cane. Oggi è un badge elettronico, un contratto a termine, una città in cui lavorare non basta a vivere.
Ma la domanda resta la stessa: Quanto siamo disposti a pagare per tenere vicino ciò che amiamo? E quando inizieremo, finalmente, a non accettare più di dover pagare per amare? Forse è tempo di smettere di sopprimere i nostri affetti… e iniziare a sopprimere il sistema che li rende un lusso.