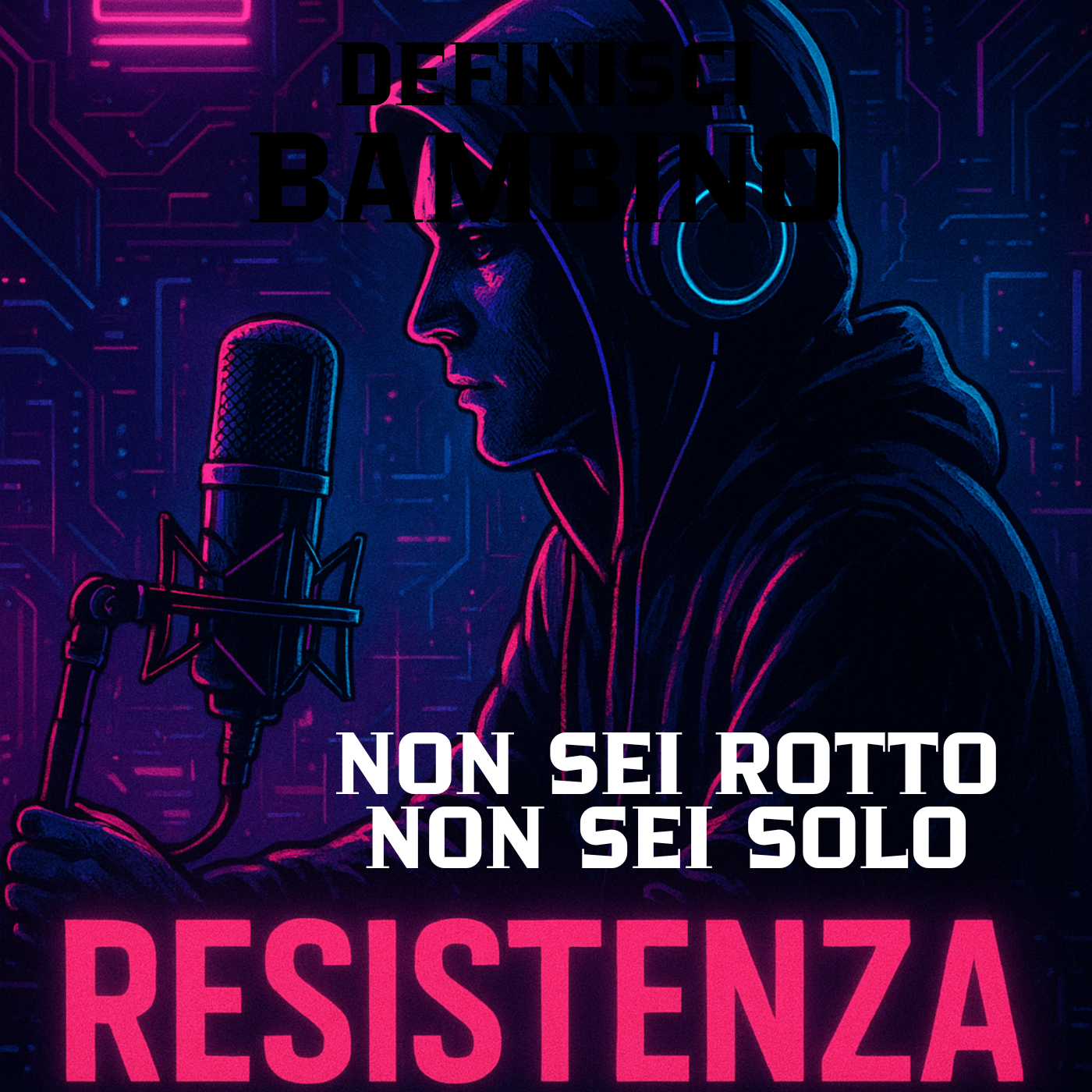Tutti cerchiamo Tadzio.
Non sempre ce ne accorgiamo. Spesso non sappiamo nemmeno dargli un nome. Ma c'è un momento, prima o poi, in cui ci ritroviamo immobili davanti a qualcosa – o qualcuno – che sembra concentrare in sé la bellezza che ci manca. Non la bellezza generica, da rivista patinata o da algoritmo Instagram, ma quella che spacca il tempo: una presenza che ci costringe a fare i conti con ciò che siamo diventati.
Nel romanzo di Thomas Mann, "La morte a Venezia", Tadzio è un ragazzino biondo, etereo, che compare in un albergo frequentato da Gustav von Aschenbach, scrittore cinquantenne, celebre, rispettato, consumato dal culto della disciplina. È un uomo che ha sempre vissuto con ordine, decoro, distacco. Poi, vede Tadzio. E tutto crolla. Non perché Tadzio dica qualcosa. Non perché lo corteggi. Ma perché, nella sua bellezza silenziosa, diventa un'ossessione. Un simbolo. Un veleno.
E noi, anche senza pandemie coleriche o hotel sul Lido, siamo pieni di Tadzio. Lo cerchiamo nei posti più impensabili. A volte lo troviamo in un ricordo, altre volte su un palco, o nel feed di qualcuno che non conosciamo nemmeno. Lo cerchiamo quando ci sentiamo vecchi, stanchi, superati. Quando il tempo ci sfugge e non sappiamo più cosa desiderare, ma sappiamo che non è questo. Che non può essere solo questo.
Tadzio è una domanda muta. Non ci dice cosa vuole. Ci mostra solo ciò che non abbiamo più.
Prima di parlare di noi, parliamo di lui. Gustav von Aschenbach non è un pervertito. Non è nemmeno un uomo di piacere. È un moralista. Uno di quelli che credono nella forma, nell'onore, nell'idea di una vita "giusta". Ma ha un problema: ha sempre represso tutto ciò che non poteva controllare. Il desiderio. L'ambiguità. L'errore. E il desiderio, si sa, più lo comprimi, più esplode.
Quando incontra Tadzio, è già consumato da qualcosa di più profondo: la paura della decadenza. Non solo quella fisica, ma quella simbolica. Il tempo inizia a deriderlo. L'ispirazione l'ha abbandonato. La vecchiaia lo accerchia. E allora, in quell'apparizione angelica e crudele, vede una possibilità. Non di futuro, ma di fuga. Fuga dalla mediocrità, dalla morte, da sé.
La psicanalisi freudiana lo spiegherebbe così: Tadzio non è un oggetto sessuale, ma una proiezione ideale. È l'Io ideale che Aschenbach ha perso. E come ogni idealizzazione, più è lontana, più si fa bruciante. È l'illusione che guardare qualcosa di perfetto possa salvarci da ciò che siamo diventati.
Il nostro Tadzio contemporaneo ha mille volti.
Può essere il corpo di un influencer, la giovinezza di un figlio, la carriera di chi è partito dopo e arrivato prima. Può essere l'amico che non ha mai sbagliato, la vita che sembrava perfetta, la bellezza che ti passa accanto e non ti vede. È tutto ciò che risveglia dentro di noi la consapevolezza del limite.
E in una cultura ossessionata dalla performance e dalla visibilità, Tadzio è ovunque. Ogni volta che apriamo Instagram e sentiamo una fitta di inadeguatezza. Ogni volta che guardiamo qualcuno e pensiamo "perché io no?", stiamo cercando Tadzio.
Ma attenzione: non è invidia. È più sottile. È il dolore del confronto tra ciò che eravamo convinti di poter diventare e ciò che siamo. È nostalgia del possibile. È lutto per il potenziale perduto.
Viviamo in una società che ha fatto della giovinezza un feticcio. Lo dicono le pubblicità, i trattamenti anti-età, i personal trainer per i cinquantenni. Ma lo dice anche il linguaggio: "non sei più quello di una volta" non è un'osservazione, è un'accusa. Perché se non sei giovane, sei in perdita.
Ma cosa c'è dietro questo culto? Il sociologo Zygmunt Bauman parlava di modernità liquida: in un mondo dove tutto cambia di continuo, solo ciò che è giovane sembra adattarsi davvero. I vecchi – o i non più giovani – diventano scarti simbolici. Non producono, non si reinventano, rallentano. Quindi diventano invisibili. E allora li vedi che rincorrono, che si rifanno la faccia, che usano TikTok. Non per esprimersi, ma per non sparire.
Tadzio, in fondo, è anche questo: la paura di non essere più rilevanti.
In tutto il romanzo, Aschenbach non parla mai con Tadzio. Lo guarda. Lo segue. Lo pedina. E questo sguardo, apparentemente innocuo, è in realtà devastante. Perché oggettifica. Trasforma l'altro in uno specchio, in una proiezione. E questo lo facciamo in continuazione. Lo facciamo coi figli, coi partner, coi corpi degli altri.
Il filosofo Byung-Chul Han, in La società della trasparenza, parla di come l'eccesso di visibilità uccida il desiderio. Quando tutto è mostrato, nulla è più misterioso. Ma il mistero non sparisce: lo riversiamo altrove. Sul giovane, sul bello, sull'irraggiungibile. Lo carichiamo di aspettative simboliche che non ha mai chiesto. E così facendo, ci condanniamo all'infelicità.
La psicologia del desiderio ci insegna che si desidera ciò che manca, ma anche ciò che ci mette in crisi. Lacan direbbe che Tadzio è il "nome-del-padre" del desiderio, qualcosa che organizza la nostra mancanza dandole una forma.
Noi non vogliamo Tadzio: vogliamo quello che Tadzio rappresenta. La bellezza perduta. L'occasione mancata. L'amore senza peso. La vita prima della caduta. E questa nostalgia non è necessariamente regressiva. A volte è il segnale che ci serve. Il sintomo che indica che qualcosa in noi chiede attenzione, cura, verità.
E quindi? Dobbiamo smettere di cercarlo? No. Ma dobbiamo renderci conto che non esiste. Tadzio non è una persona. È un sintomo. E come ogni sintomo, può essere ascoltato oppure idolatrato. Se lo ascolti, ti interroghi su ciò che ti manca, su cosa hai lasciato indietro, su come vuoi vivere davvero. Se lo idolatri, lo rincorri fino alla rovina.
Il punto non è uccidere il desiderio. Ma capire a chi appartiene.
Tutti cerchiamo Tadzio, ma pochi si chiedono perché. E forse, oggi più che mai, dovremmo cominciare a farlo. Non per giudicarci. Non per reprimerci. Ma per riconoscere che dietro ogni Tadzio che fissiamo c'è un pezzo di noi che abbiamo dimenticato di abbracciare.
Il passato che rimpiangiamo. Il futuro che temiamo. L'identità che ci siamo costruiti per piacere a qualcuno. Il corpo che ci portiamo dietro con vergogna. Le occasioni che abbiamo lasciato andare. La persona che non siamo diventati.
Guardare Tadzio può essere una condanna. Ma anche una possibilità. Dipende tutto da cosa scegliamo di vedere, davvero, quando lo fissiamo.