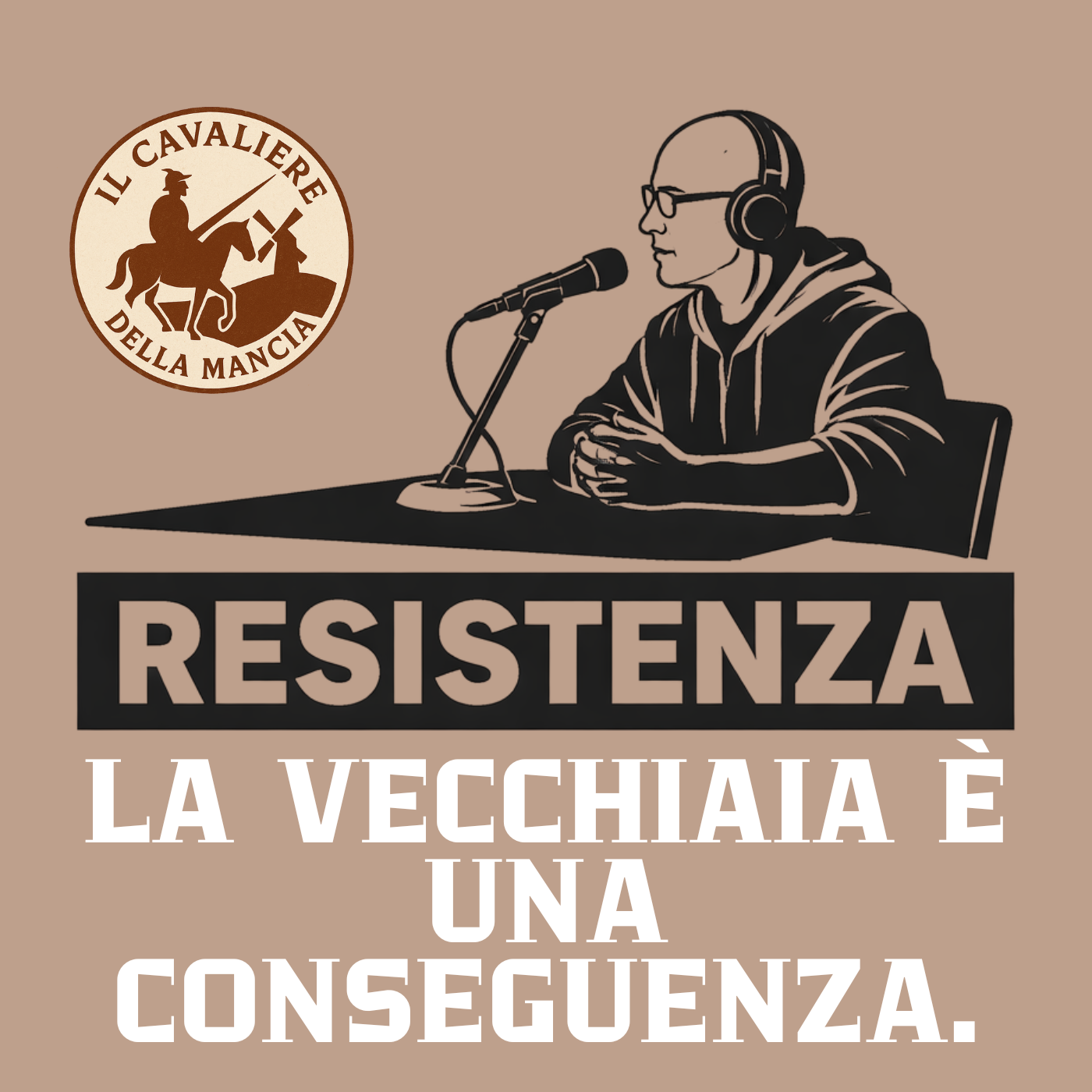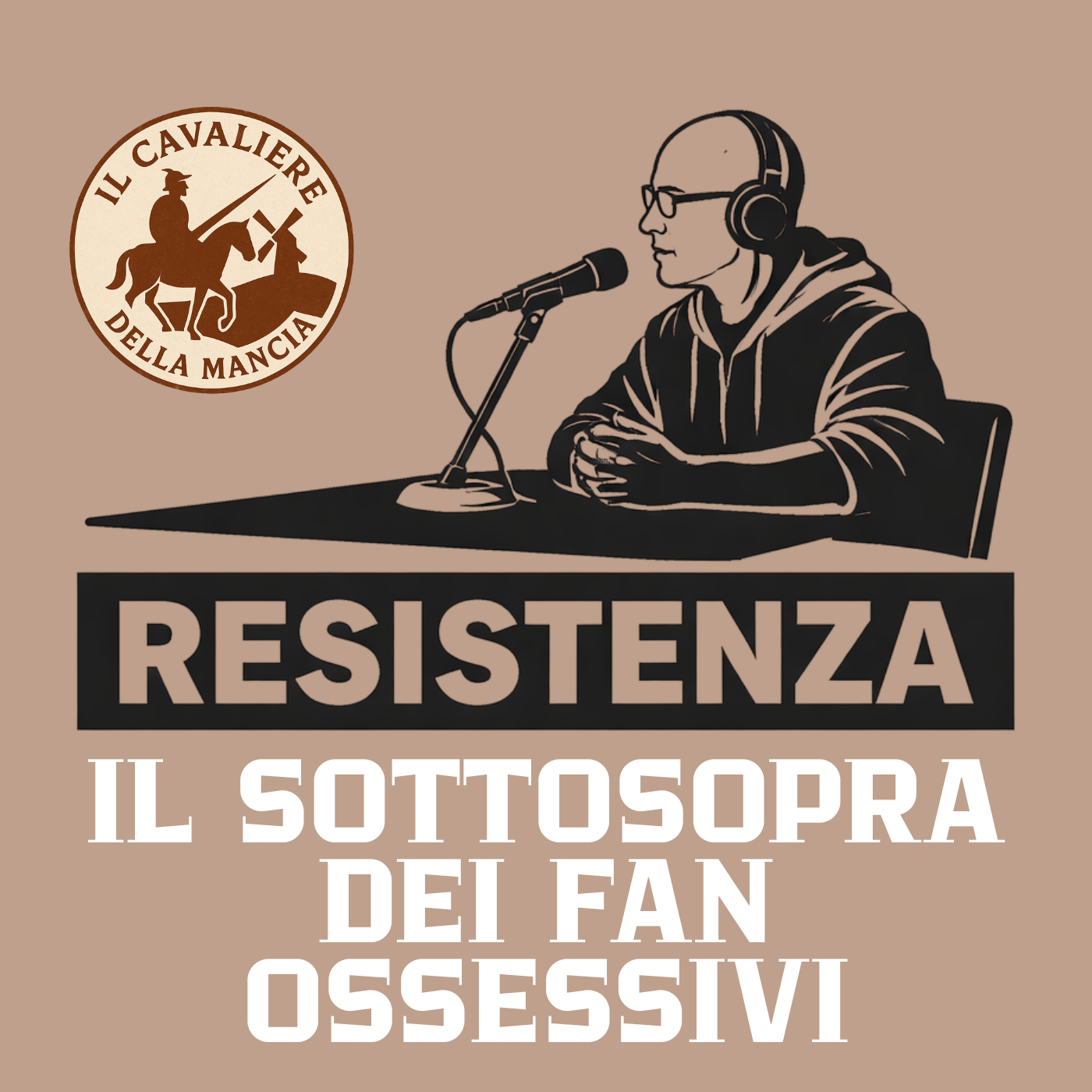C'è una frase che ritorna sempre più spesso, come l'alito del passato in un locale senza finestre: "Una volta gli imprenditori avevano la terza elementare e costruivano l'Italia. Oggi i laureati distruggono tutto."
Sembra saggezza popolare. Ma è solo una favola, buona per chi vuole sentirsi meglio senza cambiare nulla. Dietro a questa frase non c'è un elogio del lavoro, né della fatica. C'è un culto tossico dell'incompetenza legittimata. E soprattutto, c'è una profonda paura del sapere.
Che molti imprenditori italiani del dopoguerra siano partiti con poca scuola è verissimo. Ma che siano rimasti ignoranti è una menzogna colossale. Adriano Olivetti non solo leggeva Proust e Camus, ma sognava una fabbrica come città ideale. Michele Ferrero costruì una cultura aziendale fondata su formazione continua, welfare e valori cristiani. Enrico Mattei si consultava con intellettuali e studiosi: capiva che il petrolio non si estrae solo con le trivelle, ma con la diplomazia e il pensiero strategico. E vogliamo parlare di Rita Levi-Montalcini? Laureata in medicina, premio Nobel, ostacolata dal fascismo, emarginata per essere donna, ebrea, e colta. O di Primo Levi, chimico, scrittore, testimone della Storia, che spiegava Auschwitz con la lucidità di un matematico e la sensibilità di un poeta.
Non basta "essere svegli". Serve conoscere, leggere, confrontarsi. Chi non si è formato ha fallito, o è diventato cinico. Chi ha costruito davvero, lo ha fatto crescendo anche dentro.
L'ignoranza è comoda. È uno scudo. Lo diceva Erich Fromm: "L'uomo ha paura della libertà, perché implica responsabilità." Chi sa, sceglie. Chi sceglie, può sbagliare. Chi sbaglia, soffre. E allora meglio restare ignoranti: più sicuro, più facile, più "popolare". La mente, per difendersi, seleziona solo le informazioni che confermano ciò che già crede. È la famosa dissonanza cognitiva (Festinger, 1957).
Così, chi non ha studiato, odia chi ha studiato. Chi ha paura, deride chi riflette. Chi si sente escluso, costruisce una narrazione in cui "la cultura è inutile". È un meccanismo psicologico potente, ma devastante. Perché alla lunga diventa ideologia.
Oggi nei media vincono i semplificatori, i barricaderi, quelli che gridano "la gente ha fame, non ha bisogno dei libri!". I talk show danno voce ai peggiori perché "fanno share". I social premiano l'istinto, non l'argomentazione.
Come scriveva Neil Postman, "Stiamo morendo dal ridere." Nessuna dittatura della verità. Solo un rumore di fondo che svuota ogni significato. Ogni discussione diventa intrattenimento. Ogni opinione vale quanto un'altra, anche se è sbagliata. Nel frattempo, chi sa leggere i dati, capisce la finanza, scrive le leggi… fa ciò che vuole, indisturbato.
Zygmunt Bauman parlava di "società liquida": una società dove tutto scorre, nulla resta. In un mondo così instabile, la cultura sembra un lusso. Meglio la scorciatoia, meglio la furbizia. Così cresce il mito dell'uomo "pratico", "concreto", "con il buon senso".
Ma come diceva Karl Popper, "il buon senso è spesso solo un pregiudizio sedimentato."
E allora ecco i leader politici che disprezzano i professori. I miliardari che licenziano esperti perché "i dati non contano". La scuola ridotta a parcheggio, l'università a stage non pagato. Non è un caso. È una strategia: meno sai, più sei gestibile.
Don Lorenzo Milani l'aveva capito nel 1967, scrivendo Lettera a una professoressa: "La scuola siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi."
Oggi invece la scuola sembra un ingombro. Viene svilita, sottofinanziata, svilita nei contenuti. I ragazzi imparano "le soft skills", ma non leggono più Dostoevskij, non sanno chi è Gramsci, confondono Hitler con Churchill.
E mentre si tolgono ore di filosofia, aumentano le ore passate su TikTok a seguire guru che ti dicono che la scuola è una truffa e l'università ti rende schiavo.
Nel 2023 in Italia più di un giovane su due non capiva un testo scritto (dati OCSE-PISA). Ma a nessuno sembra importare davvero. Troppo complicato. Meglio parlare di "gender", di "zainetti", o di quanto è bello lavorare a 16 anni per "fare la gavetta".
Socrate diceva: "So di non sapere." Era una dichiarazione di guerra all'arroganza. La conoscenza non è accumulo, ma ricerca. Un percorso, non una medaglia.
Hannah Arendt, nel descrivere la banalità del male, ci ha insegnato che non pensare è il primo passo verso l'obbedienza cieca. Non sapere è già sottomettersi. L'ignoranza non è mai neutra: è un'arma in mano ad altri. E oggi, in una realtà dominata da A.I., deepfake, manipolazione algoritmica… l'unico modo per non essere inghiottiti è sapere.
Non si tratta di fare l'elogio del "titolo di studio". Ci sono dottori ignoranti e muratori sapienti. Ma chi ha costruito qualcosa di buono non ha mai disprezzato il sapere.
Studiare, oggi, è un atto politico. Leggere è rivoluzionario. Saper discutere, dubitare, argomentare — è resistere.
Chi si vanta di non sapere non è più "popolo": è utile idiota del potere. È carburante per l'odio. È spettatore di sé stesso.
La vera alternativa non è tra laurea e lavoro, tra sapere e fare. La vera scelta è tra coscienza e inconsapevolezza. Tra costruire e servire.
Pasolini lo scrisse con rabbia e precisione: "L'ignoranza è il vero fascismo. Non serve più reprimere, basta impedire di capire." Ecco perché dobbiamo parlare. Scrivere. Studiare.
E ricordare a ogni generazione che il sapere non è un privilegio, ma un diritto. Perché non salveranno l'Italia quelli che si vantano della propria ignoranza. La salveranno — forse — quelli che, giorno dopo giorno, scelgono ancora di imparare.