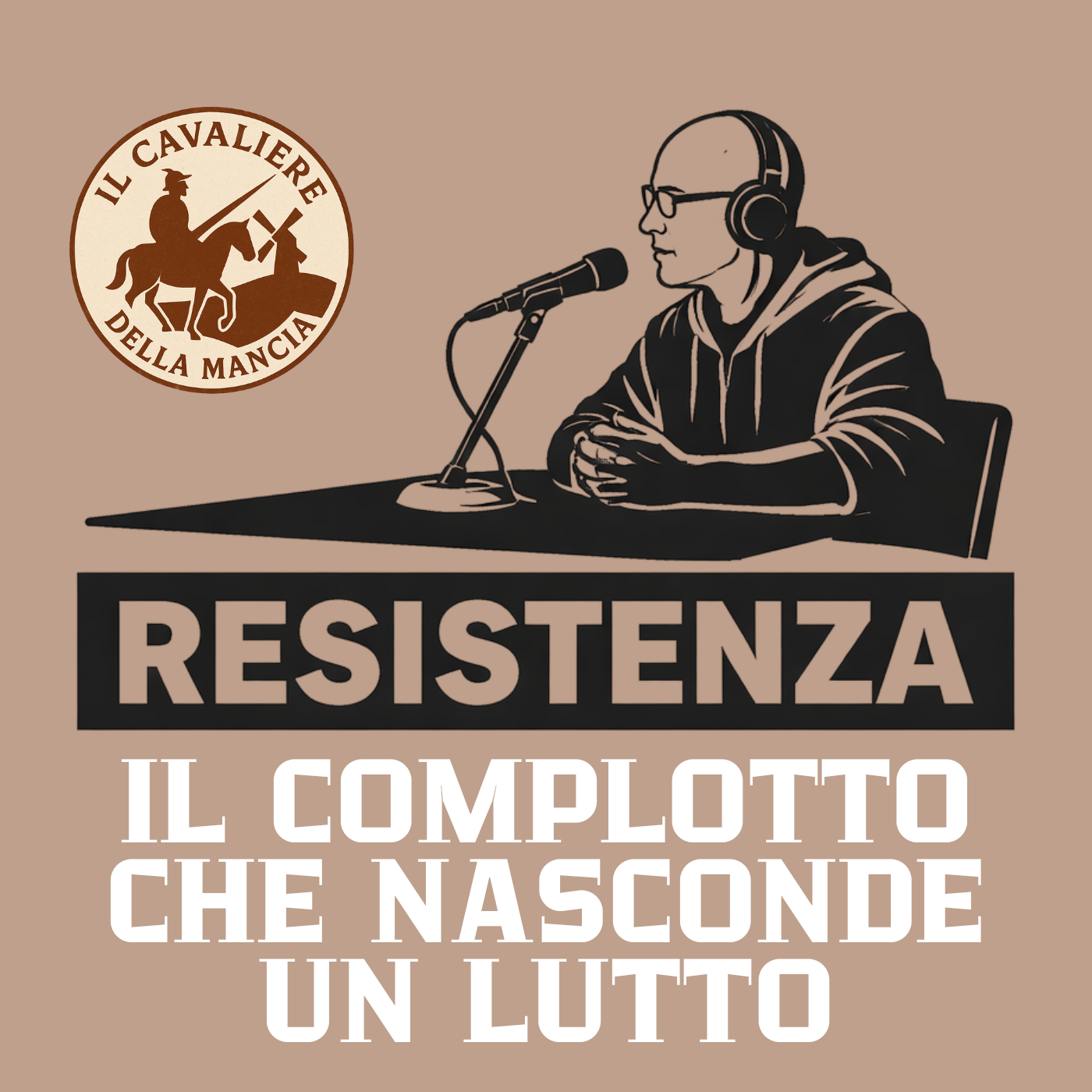In Italia, ogni sera, milioni di persone si mettono comode davanti alla TV, accendono Rai 1, e si lasciano cullare da storie di redenzione. C'è sempre una suora che consola, un peccatore che si redime, un dolore che trova ascolto, un errore che diventa occasione. Tra le più celebri: Che Dio ci aiuti. Un titolo che è già una carezza. Un balsamo. Un invito alla speranza.
Ma poi, la mattina dopo, quelle stesse persone scorrono i titoli dei giornali. "Migranti annegati nel Mediterraneo." "Affondato un barchino." "Bloccata nave ONG." E nei bar, nei salotti, nei social, i toni sono duri. Spietati. "Eh, però stanno invadendo." "Aiutiamoli a casa loro." "Hanno i cellulari, non possono essere poveri." Qualcuno propone persino: "Un missile e via."
Cosa succede nella mente di chi la sera si commuove con Sor Angela e il giorno dopo invoca le cannonate contro i disperati?
Succede che il potere conformista del racconto edificante è molto più subdolo di quanto sembri.
Che Dio ci aiuti è un prodotto costruito con maestria. Ti parla di dipendenze, prostituzione, abbandono, devianza, famiglie spezzate. Ma lo fa dentro un recinto protetto. Un convento che somiglia a un resort, una suora che sembra una life coach, una squadra di personaggi fragili ma simpatici, problematici ma redimibili.
Il dolore è sempre presente, ma addomesticato. Raccontato in modo da non disturbare davvero. C'è il trauma, ma mai l'ingiustizia sistemica. C'è l'errore, ma non il contesto che lo genera. Il messaggio è chiaro: "Hai sbagliato, ma puoi rimediare."
Il problema? Questa è una narrazione costruita per il benessere emotivo dello spettatore, non per l'inquietudine etica. Serve a placare, non a mettere in discussione.
Suor Angela, in particolare, è una figura ambigua. Simpatica, empatica, affettuosa — ma profondamente invasiva. Dietro il sorriso rassicurante c'è una presenza costante, a volte ossessiva, che impone la sua visione del mondo. Sempre per il bene degli altri, certo. Sempre con le migliori intenzioni. Ma in modo innegabilmente tossico.
Suor Angela non chiede: indica. Non accompagna: dirige. Non ascolta: giudica dolcemente e poi agisce secondo ciò che lei ritiene giusto.
E allora, mentre lo spettatore si emoziona per la ragazza madre che trova un lavoro grazie alla suora (vedi l'episodio 2x04, dove Chiara riesce a inserirsi in una cooperativa), non si chiede mai perché una ragazza madre in Italia sia costretta a vivere in quelle condizioni.
La fiction offre una scorciatoia emotiva. Ti fa sentire buono senza costringerti a fare nulla. Ma soprattutto: ti fa accettare il sistema, non ti fa combatterlo.
Le storie si concludono sempre con un reintegro nell'ordine, mai con una messa in discussione dell'ordine stesso. L'emancipazione è individuale, non collettiva. Il riscatto avviene dentro le regole, non contro le regole. Il disagio sociale viene ridotto a problema morale.
E qui si insinua silenziosa, ma pervasiva, una filosofia calvinista e capitalista della colpa: se soffri, è colpa tua. Se ti redimi, sei degno. Se fallisci, sei maledetto. Non c'è spazio per la lotta collettiva, per l'analisi delle strutture, per la rabbia politica. Solo per la salvezza individuale, condizionata al merito e alla sottomissione.
C'è un meccanismo psicologico tanto diffuso quanto pericoloso: l'empatia selettiva. Siamo capaci di provare emozione solo dentro un contesto che ci fa sentire al sicuro. E la fiction è quel contesto.
Sor Angela sorride, ascolta, consola. Non ti fa mai sentire a disagio. Il suo amore è ordinato, pedagogico. È l'amore che ti accoglie se ti fai accogliere bene.
Ma il migrante che arriva con la barba lunga, sporco, arrabbiato, che parla una lingua che non capisci, che non ti chiede "per favore", ma reclama diritti? Quello no. Quello spezza il frame. Ti mette in crisi.
E allora il cervello, pur di non affrontare quella frattura, disinnesca l'empatia. La gira in rabbia.
Chi piange con la fiction si convince di essere una brava persona. Ma quella commozione è sterile. Non genera trasformazione. Non si traduce in scelta politica, in azione concreta, in messa in discussione. È solo catarsi da divano.
Sui social, a ogni tragedia in mare, c'è chi commenta: "Peccato. Ma noi abbiamo già i nostri poveri." O peggio: "Che muoiano. Sono solo criminali."
E magari è la stessa persona che ha condiviso la clip in cui Sor Angela salva un senzatetto dalla solitudine natalizia.
Le fiction buoniste funzionano come un deodorante spruzzato su una discarica. Fanno profumo, ma non puliscono nulla.
In un Paese in cui le disuguaglianze aumentano, il razzismo cresce, la scuola viene smantellata, la sanità privatizzata e i diritti compressi, cosa fa la televisione pubblica? Mette in scena il dolore, ma in forma light. Drammatizza la sofferenza, ma senza disturbare l'ordine delle cose.
Suor Angela non fa rivoluzioni. Consola.
La carità prende il posto della giustizia. La morale individuale sostituisce la responsabilità collettiva.
Il povero non è più un cittadino da tutelare, ma un personaggio da salvare. Ma solo se si comporta bene. Se accetta l'aiuto, se si pente, se si redime.
Il messaggio implicito è devastante: i problemi sociali sono colpa dell'individuo. Se sei povero, deviante, disperato, drogato, migrante, è perché hai sbagliato. Però — dai — ti diamo un'altra possibilità. A patto che righi dritto.
Altre fiction italiane seguono lo stesso schema:
Don Matteo, dove il parroco-poliziotto risolve tutto col buon cuore e qualche stratagemma morale;
Mare Fuori, che prova a raccontare la devianza giovanile ma, nelle sue derive, trasforma l'ICAM in un palcoscenico emotivo, più che in un luogo dove analizzare le vere radici della marginalità;
Braccialetti Rossi, dove la malattia diventa occasione di crescita personale, mai un grido politico contro il disastro della sanità pubblica.
Ed eccoci al paradosso più scomodo.
Più la televisione si riempie di storie buoniste, più la società si incattivisce. Più si narra la redenzione, più cresce la repressione. Più la suora sorride, più la gente vota chi promette manganelli.
Sembra assurdo, ma ha una logica.
La fiction lavora su un doppio livello:
offre un'esperienza emotiva intensa ma innocua;
rinforza un'idea dell'ordine sociale che
non va messo in discussione.Suor Angela non lotta per cambiare il sistema. Ti dice che puoi trovare un posto nel sistema, se ti impegni, se hai fede, se sei buono. È la stessa ideologia del self-help applicata alla fiction: "la colpa è tua, ma puoi farcela".
Chi guarda si convince che i problemi della società derivino da cattive scelte individuali. E che chi non si "redime" meriti l'esclusione. Da qui alla legittimazione dell'odio, il passo è breve.
Il passaggio da "ti aiuto" a "ti affondo" è solo questione di come percepisco la tua disponibilità a essere salvato.
C'è un modo per raccontare la sofferenza senza renderla strumento di consolazione. Ed è il racconto che non consola, che disturba, che obbliga a fare i conti con le proprie responsabilità.
È il teatro politico. È il cinema sociale che non edulcora. È il documentario. È la letteratura scomoda. È quella narrazione che non redime, ma rivolta.
Serve una fiction che non dica: "Puoi essere accolto se cambi." Ma: "Forse sei così perché il mondo ti ha reso così. E quel mondo dobbiamo cambiarlo."
Non ci serve la suora col sorriso. Ci serve il testimone che urla.
Sor Angela è l'angelo della consolazione. Ma la sua presenza, così pacificatrice, così positiva, è anche il segnale di un problema più grande: l'illusione che si possa cambiare il mondo senza cambiare nulla.
Queste fiction costruiscono un mondo dove tutto si può risolvere con un gesto buono, un consiglio giusto, una lacrima nel momento opportuno. È un mondo in cui si soffre solo per colpa o destino, mai per ingiustizia strutturale.
Ed è proprio questo, paradossalmente, che rende più facile l'odio.
Perché se davvero la redenzione è alla portata di tutti — come ci raccontano ogni sera — allora chi resta fuori è colpevole. E come ogni colpevole, può essere punito.
Alla fine, il vero miracolo di queste fiction non è la salvezza dei personaggi. È l'assoluzione dello spettatore.
"Io sono una brava persona. Piango davanti alla TV. Ma nella realtà non mi fregate. E se venite col barcone, vi affondo."
Che Dio ci aiuti. Ma a salvarci, stavolta, non sarà una suora.