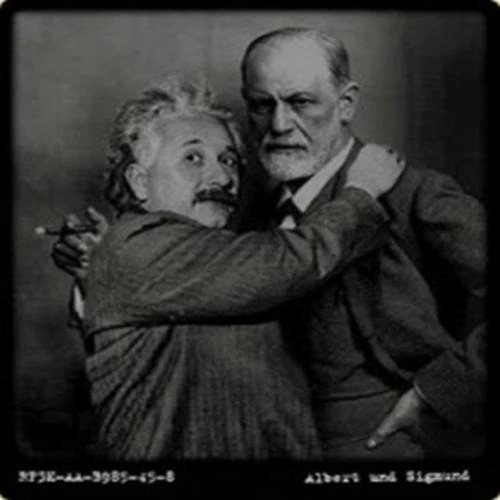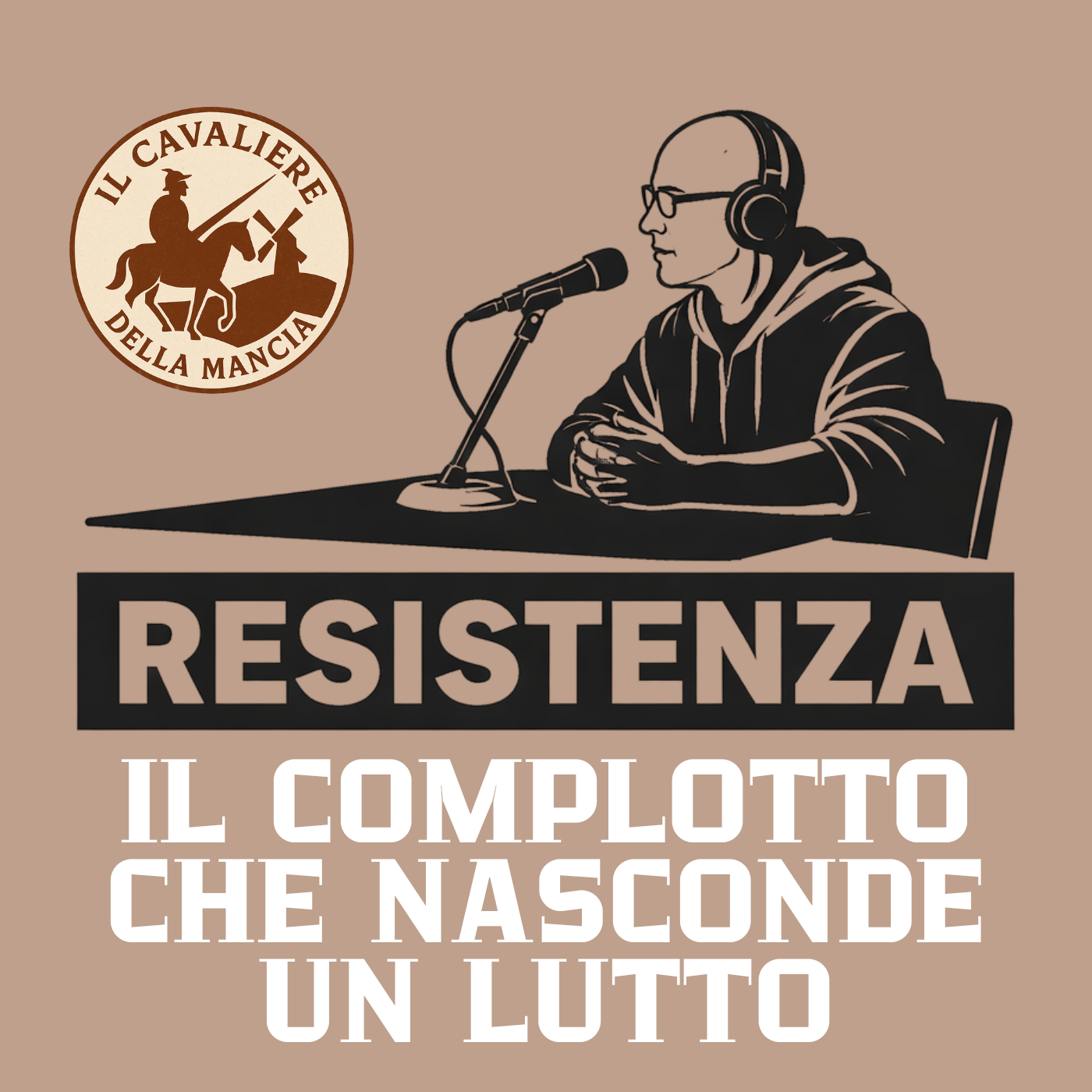Immaginate un uomo che ha visto l'universo. Non per modo di dire: ha scritto le equazioni che spiegano il tempo, la materia, lo spazio. Eppure, nel 1932, quello stesso uomo prende carta e penna per chiedere aiuto. Non a un collega fisico, ma a uno psicanalista.
Albert Einstein scrive a Sigmund Freud.
Il tema? Il più terrestre, il più ricorrente, il più insensato degli eventi umani: la guerra.
La domanda è semplice, definitiva, bruciante:
"C'è un modo per liberare l'umanità dalla guerra?"
Siamo alla vigilia del disastro. Il nazismo sta per prendere il potere in Germania. La Società delle Nazioni, nata per evitare un secondo conflitto mondiale, è un organismo anemico, più simbolico che reale.
Einstein ha già capito tutto. La scienza non basta. Le leggi non bastano. Serve una trasformazione profonda — culturale, psicologica, forse antropologica. Per questo sceglie Freud, l'uomo che ha osato mettere le mani nell'inconscio.
Il carteggio è parte di un progetto della Lega delle Nazioni chiamato "Perché la guerra?": chiedere ai grandi intellettuali del tempo di confrontarsi sul male radicale della violenza organizzata.
La lettera di Einstein è un'esposizione limpida ma spietata. Le nazioni — scrive — agiscono in base ai loro "interessi", ma questi interessi sono spesso costruiti da minoranze di potere: caste militari, industriali, politiche.
Le masse? Seguono, spinte dalla propaganda e da pulsioni che sembrano fuori controllo.
Einstein riconosce che il diritto internazionale non ha strumenti: senza un monopolio legittimo della forza, la pace resta un'utopia.
"Solo una autorità sovranazionale potrebbe impedire la guerra," scrive. Ma poi si ferma. Sa che un'autorità simile non esiste. E allora chiede a Freud:
possiamo, almeno, cambiare l'uomo?
La risposta di Freud è brutale, quasi gelida.
"La guerra è espressione di una pulsione umana fondamentale: la pulsione di morte."
C'è in noi un bisogno di distruggere, dominare, aggredire. Non è solo cultura. È istinto. E questo istinto, scrive, non può essere eliminato. Al massimo, può essere spostato, sublimato, civilizzato.
Il conflitto, per Freud, nasce dalla tensione tra Eros e Thanatos: amore e distruzione, cooperazione e violenza. Due forze in lotta dentro ciascuno di noi. La civiltà è il risultato di questa lotta — e anche il suo campo di battaglia.
Freud non si illude. "Ogni rinuncia pulsionale è pagata con un impoverimento del sé."
Eppure, suggerisce, possiamo lavorare su due fronti:
rafforzare i legami affettivi e culturali tra le persone, per trasformare l'altro da nemico a simile;
educare alla razionalità, cioè a contenere l'impulso distruttivo con strumenti interiori.
La lettera è del 1932. Un anno dopo Hitler è cancelliere. Nel 1939 comincia la Seconda Guerra Mondiale. Freud morirà in esilio. Einstein si trasferirà definitivamente negli Stati Uniti.
Nessuno li ascoltò davvero.
Eppure questo scambio resta un documento lucidissimo su come funziona la violenza, da dove nasce, e perché non basta gridare "pace" per ottenerla. Serve un lavoro più profondo, più lungo, più faticoso: la trasformazione della mente collettiva.
Se Einstein ci chiedesse oggi "È possibile liberare l'umanità dalla guerra?", la psicologia non risponderebbe più come nel 1932. O almeno: non solo.
Certo, l'aggressività fa parte del repertorio umano. Ma sappiamo molto di più su come si sviluppa, si alimenta e si può disinnescare.
Studi sulla costruzione del nemico, sulle dinamiche del trauma collettivo, sul ruolo dell'identità di gruppo, dimostrano che la guerra non è solo un'esplosione di impulsi, ma un costrutto sociale, che può essere prevenuto e contrastato.
Modelli come "contact hypothesis" di Allport, le pratiche di giustizia riparativa, i percorsi di elaborazione del lutto sociale e le politiche di riconciliazione, dimostrano che l'essere umano può anche scegliere un'altra via.
Ma nulla accade da solo.
La pace è una costruzione attiva, non uno stato naturale.
E questo Freud lo sapeva benissimo. Anche se non lo diceva con le parole di oggi.
Freud aveva ragione: non possiamo eliminare la pulsione aggressiva. Ma possiamo trasformarla.
Non con la censura, né con la retorica. Ma con l'educazione emotiva, la cura del legame, la responsabilità culturale.
Forse, se Einstein e Freud si parlassero oggi, la conversazione sarebbe meno disperata. Non ottimista — non è questo il tempo per ottimismi. Ma più consapevole che la guerra non è inevitabile. È il frutto di scelte.
E quindi, anche la pace, lo può essere.a