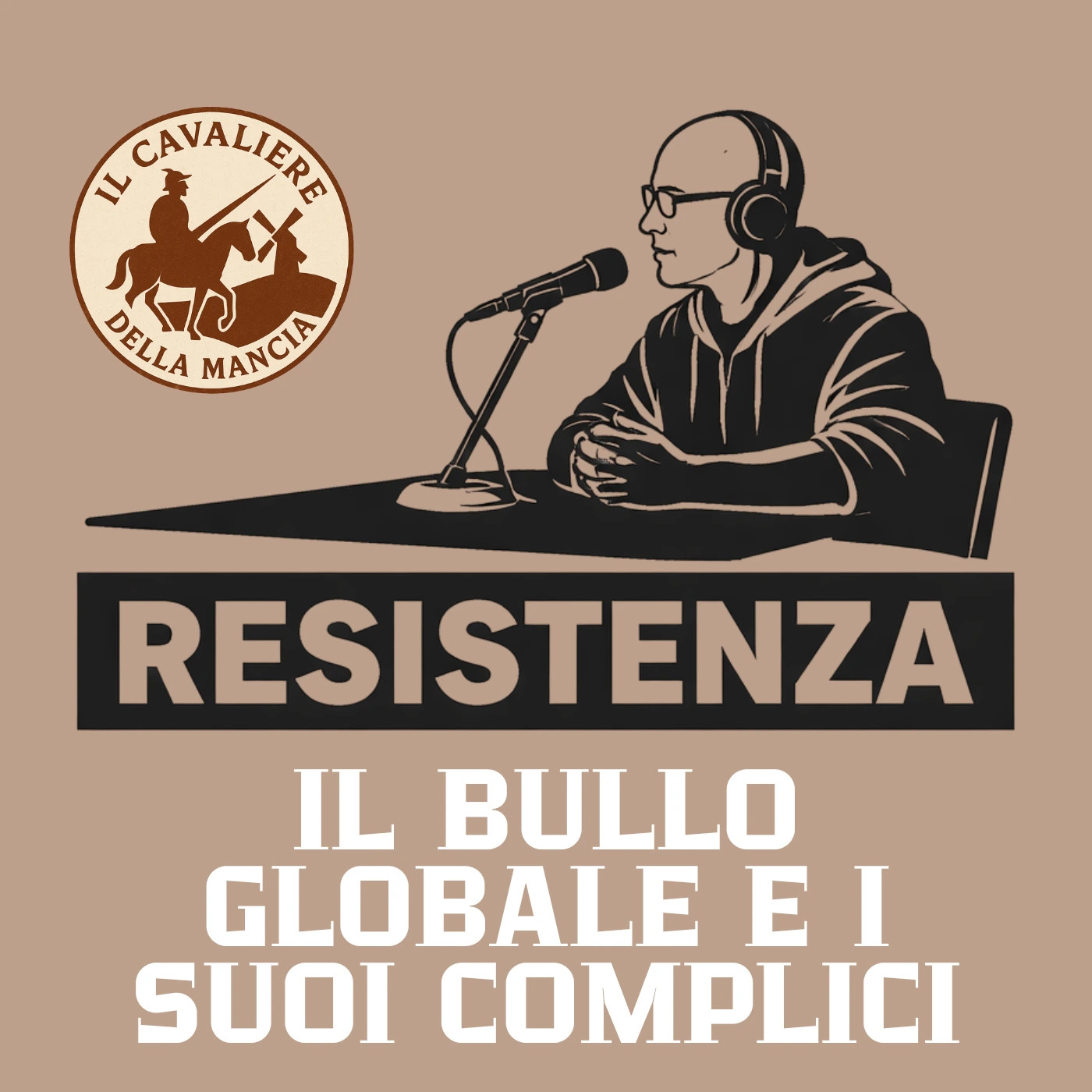C'era una volta una persona che viveva una vita a metà. Non perché non avesse possibilità o talento, ma perché non riusciva a mostrarsi per ciò che era davvero. Viveva sotto lo sguardo pesante della propria famiglia, con un senso di giudizio sempre addosso, e alla fine scelse la strada più sicura: adeguarsi.
Ma il corpo non dimentica. Quello che la mente tiene chiuso a chiave, il corpo lo urla. Nel suo caso, la battaglia si spostò sul cibo. Chili accumulati come un'armatura, abbuffate come anestetico, e poi diete drastiche e interventi chirurgici come colpi di frusta contro se stesso. Un'intera esistenza spesa a difendersi non dai nemici, ma da quella parte di sé che non riusciva a vivere liberamente.
Questa non è una storia isolata. È piuttosto l'esempio di un meccanismo antico, che attraversa secoli e culture: quando la società impedisce di esprimere i propri desideri e le proprie paure, quando il linguaggio manca o viene soffocato, il corpo diventa il campo di battaglia. Non importa che si tratti del Medioevo o del presente, che si viva nella fame o nell'abbondanza: il corpo parla sempre, e trova ogni volta nuove armi con cui farlo.
La psicosomatica parte da un'intuizione semplice: ciò che non si può dire, si somatizza. Le emozioni represse, i conflitti irrisolti, la vergogna e la paura non svaniscono nel nulla. Restano in circolo, e prima o poi si incarnano. Il corpo diventa allora un linguaggio alternativo, un teatro dove la psiche recita i drammi che la società non vuole ascoltare.
Ma questo linguaggio non è mai neutro: cambia con i tempi. Ogni epoca produce i propri sintomi, le proprie ferite "di moda". Dove oggi abbiamo obesità, disturbi alimentari, dipendenze e ossessioni per l'immagine, ieri c'erano le convulsioni isteriche, i digiuni mistici, le stigmate, le ulcere. Cambiano le forme, resta intatto il meccanismo: il corpo si fa portavoce di un'anima che non trova ascolto.
Oggi siamo circondati da cibo. L'abbondanza non è solo materiale, ma anche simbolica: le pubblicità ci bombardano, il supermercato è un tempio sempre aperto. Non sorprende che il cibo sia diventato il nostro linguaggio psicosomatico principale. Mangiare troppo o non mangiare affatto, abbuffarsi in segreto o contare ossessivamente le calorie, ingrassare fino a scomparire dentro la massa del corpo o dimagrire fino a scomparire per mancanza: sono tutte strategie di sopravvivenza psichica.
Il corpo ingrassato diventa barriera, protezione, talvolta castigo. Il corpo anoressico diventa rifiuto, purificazione, controllo assoluto su se stessi quando tutto il resto sfugge.
Ma non è sempre stato così. Se andiamo indietro di qualche secolo, troviamo società in cui il cibo era scarso, e allora la battaglia non poteva giocarsi sull'abbondanza. Lì il sintomo prendeva altre vie.
Nel Medioevo, soprattutto fra le donne, esisteva una forma di devozione estrema che consisteva nel rifiutare il cibo. Non c'erano supermercati, non c'erano diete iperproteiche. Eppure ci sono testimonianze di "sante anoressiche" che vivevano quasi senza mangiare, nutrendosi soltanto di ostie consacrate.
Da un punto di vista religioso, si trattava di un atto di purezza e di vicinanza a Dio. Ma la lettura psicologica ci dice altro: quel digiuno era un modo di affermare il controllo sul proprio corpo in un'epoca in cui le donne non avevano controllo su nient'altro. Era anche una maniera di trasformare l'impossibilità di esprimere desideri e frustrazioni in un sacrificio legittimato dal contesto culturale. La repressione sessuale, i vincoli sociali, la mancanza di autonomia trovavano un canale nel corpo che rifiutava il nutrimento.
Il digiuno diventava così l'arma del corpo medievale. Non c'era grasso da accumulare, ma c'era un cibo da rifiutare. E il messaggio era forte: "non sono schiava di voi, perché neppure la fame mi domina".
Arriviamo al XIX secolo, all'epoca vittoriana e alla nascita della psicoanalisi. Qui il sintomo cambia ancora forma. La società borghese reprime in modo feroce la sessualità, soprattutto quella femminile. Non potendo esprimere né desideri né frustrazioni, molte donne sviluppano i cosiddetti sintomi isterici: paralisi improvvise, cecità senza cause organiche, convulsioni, svenimenti, dolori misteriosi.
Freud parlò di "conversione": l'angoscia si converte in sintomo fisico. Il corpo "traduce" in dolore ciò che la parola non può pronunciare. Non c'è abbondanza di cibo, ma abbondanza di regole, di silenzi, di rigidità. E il corpo diventa il luogo dove quelle regole esplodono in forme incontrollabili.
L'isteria è stata la grande arma psicosomatica dell'età moderna: visibile, spettacolare, incomprensibile per i medici, ma chiarissima come linguaggio del dolore psichico.
Con il passaggio al Novecento e alle società industriali, i sintomi si trasformano ancora. Qui non è più tanto il sesso a essere represso, quanto la tensione lavorativa, la frenesia del ritmo urbano, la pressione a essere produttivi. Il corpo allora si ribella sotto forma di ulcere gastriche, ipertensione, malattie da stress.
Il linguaggio psicosomatico si adegua al contesto: in un mondo che misura il valore delle persone sulla base del lavoro, il corpo si ammala proprio nel punto in cui lavora di più, lo stomaco che deve digerire ritmi impossibili, il cuore che pompa a mille senza tregua.
Torniamo al presente. L'abbondanza alimentare, unita al culto dell'immagine, ha trasformato il corpo in una vetrina. Non basta più sopravvivere, bisogna apparire belli, sani, desiderabili. In questo scenario, i disturbi alimentari esplodono. Anoressia, bulimia, binge eating: tre facce diverse dello stesso conflitto, tutte legate all'uso del cibo come arma psicosomatica.
Il grasso diventa colpa, vergogna, e al tempo stesso protezione. La magrezza estrema diventa virtù, purezza, ma anche negazione della vita. L'abbuffata diventa anestesia, un modo per silenziare l'ansia e la solitudine.
Il corpo, ancora una volta, porta le cicatrici di un conflitto che non si riesce a dire a voce: il conflitto fra l'essere e l'apparire, fra il desiderio e il dovere sociale, fra il bisogno di accettazione e la paura di rifiuto.
Guardando questa lunga linea del tempo, quello che colpisce non è la differenza, ma la continuità. In ogni epoca, il corpo ha preso in carico i conflitti della psiche. Ha trovato sempre nuove armi, a seconda dei materiali disponibili.
Nell'epoca della scarsità, il digiuno e la malattia.
Nell'epoca della repressione sessuale, l'isteria.
Nell'epoca della fabbrica e del lavoro, le ulcere e l'ipertensione.
Nell'epoca dell'abbondanza e dell'immagine, i disturbi alimentari e le ossessioni per il corpo.
È sempre lo stesso copione: ciò che non si può dire, il corpo lo mette in scena.
La domanda aperta è: quale sarà la prossima arma del corpo? Già oggi vediamo nuovi sintomi emergenti: dipendenze da tecnologia, ansia da prestazione digitale, insonnia da iperconnessione. Forse il futuro sarà un corpo stremato dall'eccesso di stimoli, non più dal cibo ma dalla luce degli schermi, dai ritmi incessanti delle notifiche.
Quello che resta certo è che il corpo continuerà a parlare. Perché, al di là delle mode e delle epoche, la psiche trova sempre un modo di incarnarsi. Possiamo scegliere se ascoltarla o lasciare che il sintomo esploda.
Il corpo, insomma, non mente mai. Cambia linguaggio, ma non smette di raccontare. È il campo di battaglia dove la storia personale e quella collettiva si intrecciano. La vera sfida non è eliminare i sintomi, ma capire cosa stanno cercando di dirci.