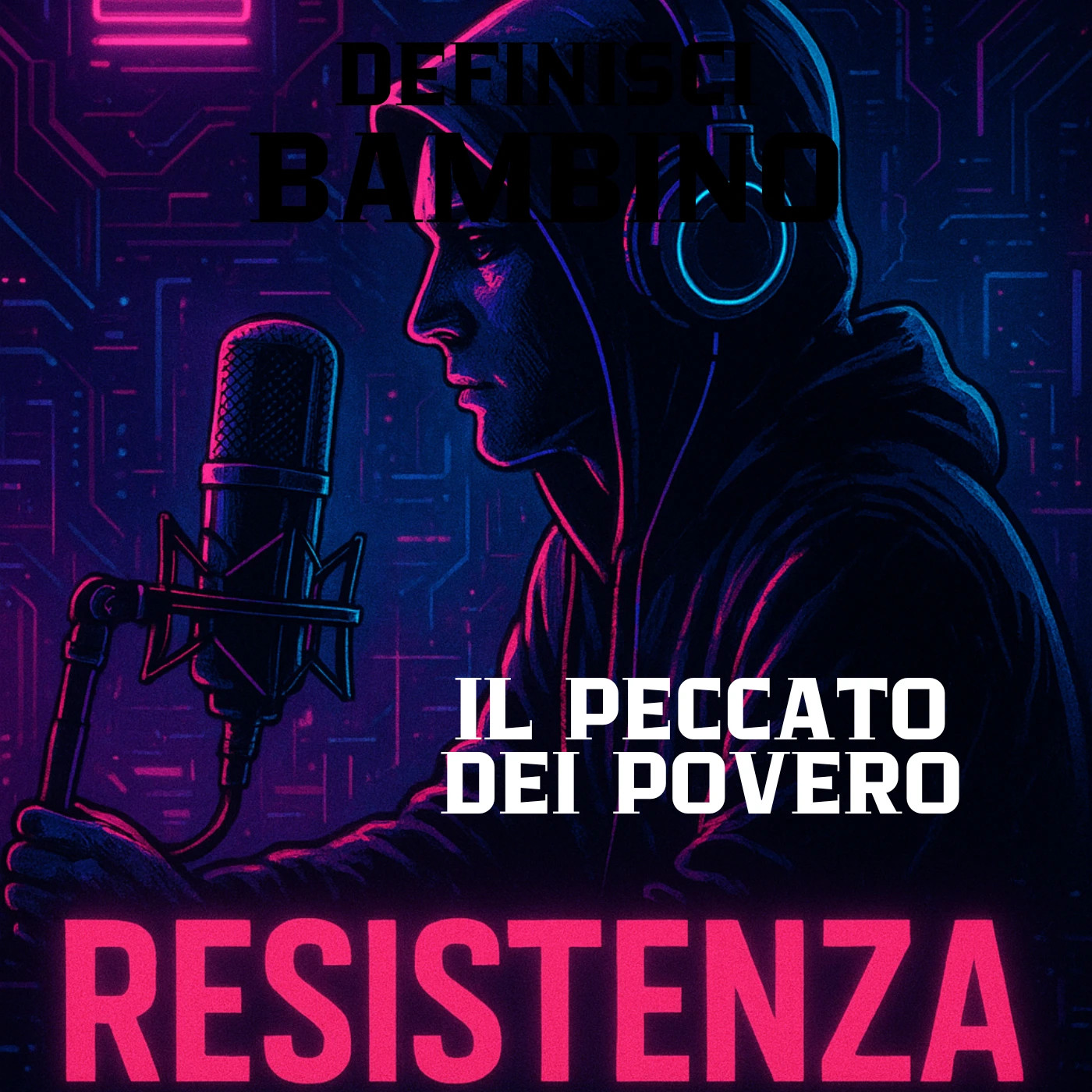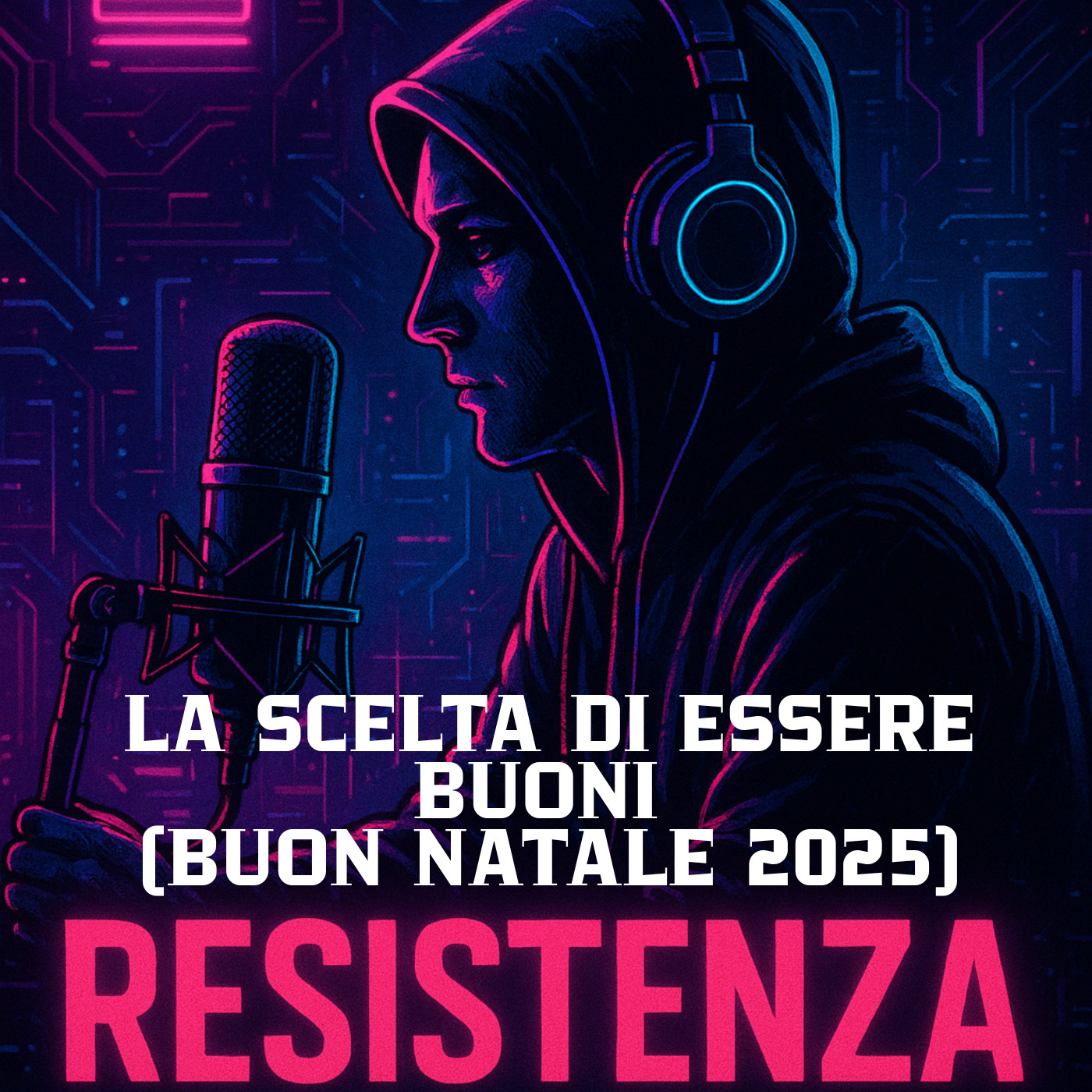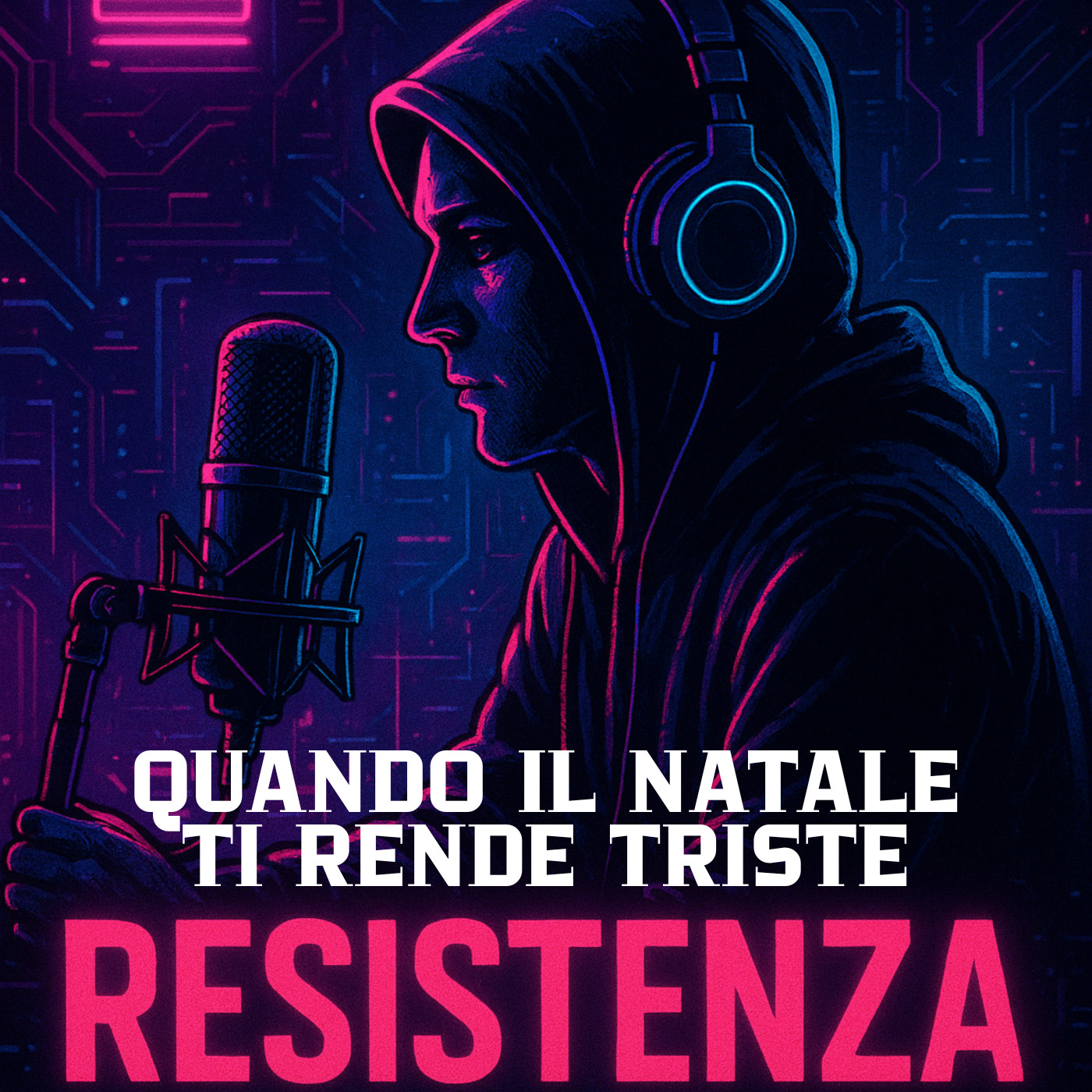C'è un tratto di teologia, sottile ma profondo, che attraversa la storia d'Europa e si insinua nelle fondamenta del capitalismo contemporaneo: l'idea che il successo non sia soltanto un traguardo, ma un segno della grazia.
È un pensiero antico, nato nelle pieghe del protestantesimo e poi mutato, secolarizzato, travestito da "spirito d'impresa". Ma sotto i grafici e le start-up, dietro le campagne politiche e le pubblicità motivazionali, sopravvive intatta la vecchia dottrina: chi ce la fa, è degno; chi resta indietro, è colpevole.
Martin Lutero non voleva fondare un'economia morale, ma la sua idea di salvezza solo per fede e grazia aprì un varco. Se l'uomo è impotente davanti al proprio destino, ma Dio può scegliere di salvarlo, allora ogni gesto quotidiano diventa un tentativo di dimostrare — a sé e al mondo — di essere tra gli eletti. Con Giovanni Calvino, questo pensiero si fece più duro: Dio ha già deciso tutto. I salvati e i dannati sono scritti da sempre. Tuttavia, il successo terreno può essere un indizio della grazia divina. Non la causa, ma il segno. Da lì, la deriva fu inevitabile: la ricchezza come prova della virtù, la povertà come marchio del peccato.
Max Weber lo capì benissimo nel suo celebre saggio L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Il capitalismo moderno, scriveva, non nasce solo dall'avidità ma da un'ansia religiosa. L'uomo moderno lavora senza sosta, accumula, reinveste, non per godere ma per salvarsi. L'accumulazione diventa vocazione morale, non solo economica. Quando Dio sparisce, resta la macchina. E quella macchina non perdona: chi non produce, chi non performa, chi non scala, è un peccatore laico.
Così, cinque secoli dopo, ci ritroviamo in un mondo che predica la meritocrazia come nuova fede. Un mondo in cui il valore di una persona non è misurato dalla sua dignità, ma dal suo rendimento. Il linguaggio della religione è scomparso, ma il dogma no: chi ha successo "se l'è meritato", chi fallisce "non si è impegnato abbastanza". Non importa se sei nato in una famiglia povera, in una regione dimenticata, o in un quartiere dove la scuola cade a pezzi. Se non "ce la fai", è colpa tua. E la colpa — lo sappiamo — è lo strumento di controllo più efficace mai inventato.
La politica di una certa parte cavalca esattamente questa narrazione. Si taglia il welfare in nome della responsabilità individuale. Si smantella la sanità pubblica dicendo che "i soldi non ci sono", mentre si detassano i grandi patrimoni. Si colpevolizzano i disoccupati, i migranti, i malati, i precari. Non sono vittime di un sistema ingiusto: sono "fannulloni", "assistiti", "non resilienti".
E il popolo, bombardato da decenni di propaganda economico-religiosa, ci crede. Ci crede davvero. Pensa che la colpa non sia del sistema, ma sua. Che la povertà sia un difetto morale. Che se nasci a Crotone e non riesci a emergere come chi nasce a Milano, la colpa è tua, non del divario economico, delle scuole abbandonate, dei treni che non passano, delle opportunità che non esistono. È un capolavoro ideologico: un sistema che ti schiaccia, e nel frattempo ti convince che meriti di essere schiacciato. È la teologia della colpa travestita da economia. E funziona, perché è semplice, intuitiva, apparentemente giusta. Nessuno vuole sentirsi vittima, e così diventiamo carnefici di noi stessi.
Il capitalismo morale ti dice: puoi farcela. Ma se non ce la fai, è solo colpa tua. Un'illusione perfetta, che anestetizza la rabbia e trasforma la frustrazione in vergogna. Non ci si ribella a un sistema che sembra giusto: si cerca di piacergli di più. E così lavoriamo sempre, ci auto-sfruttiamo, competiamo gli uni contro gli altri. Zitto. Lavora. Compra. E se sei infelice, vai a motivarti su YouTube.
Il paradosso è che oggi adoriamo i nuovi "santi del profitto": Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump. Li chiamiamo "self made men", ma sono figli di miliardari, allevati dentro il privilegio. Eppure, diventano simboli di libertà, modelli di riscatto, idoli da imitare. La loro ricchezza è il nostro rosario. Ne invochiamo i nomi come preghiere laiche: chi si impegna ce la fa. E mentre lo facciamo, interiorizziamo la menzogna: che la disuguaglianza sia naturale, che la fortuna sia merito, che la miseria sia una colpa.
La politica alimenta questo culto, perché conviene. Un popolo colpevole non protesta, non chiede giustizia: si auto-accusa. Accetta stipendi da fame "perché almeno un lavoro ce l'ho". Accetta tagli alla scuola "perché bisogna stringere la cinghia". Accetta che l'università diventi un lusso, che la sanità si compri, che la casa sia un privilegio. Accetta, e applaude. Applaude chi lo impoverisce, perché crede che sia giusto così.
L'educazione, la cultura, la conoscenza sono i veri nemici di questo sistema. Perché una mente istruita capisce che la povertà non è una colpa, ma una conseguenza. Che la fortuna non è un merito, ma una condizione. Che nessuno "si fa da solo": siamo tutti prodotti di contesti, opportunità, privilegi invisibili o mancanze strutturali. Ma un popolo tenuto nell'ignoranza — o meglio, nella distrazione — non ha strumenti per capirlo. E allora preferisce pensare che sia lui il problema. È meno doloroso credere di essere un fallito, che ammettere di vivere in un sistema ingiusto.
La verità è che il capitalismo, come una religione, ha bisogno dei suoi fedeli. Ha i suoi dogmi (crescita infinita, competizione, merito), i suoi sacerdoti (gli economisti televisivi, i CEO carismatici, i politici aziendisti), e i suoi riti (il Black Friday, i like, il culto del successo personale). Ha perfino la sua escatologia: la promessa di un futuro migliore che non arriva mai. E come ogni religione, funziona perché offre senso — anche se falso.
L'antidoto non è il cinismo. È la consapevolezza. Capire che l'essere umano non è un capitale da far fruttare, ma una creatura sociale che esiste solo nella relazione con gli altri. Che la dignità non si misura in denaro, ma nella capacità di riconoscere la dignità altrui. Che la giustizia non è carità, ma equilibrio. E che l'etica non ha bisogno di un paradiso, né di un profitto, per esistere.
Solo quando smetteremo di credere che il fallimento sia un peccato, potremo iniziare a costruire una società decente. Una società dove il benessere collettivo valga più del successo individuale. Dove il lavoro non sia una condanna ma un mezzo per vivere, non per salvarsi. Dove la libertà non significhi "ognuno per sé", ma "nessuno lasciato indietro".
Finché invece continueremo a pregare davanti al dio del mercato e a credere che la colpa sia solo nostra, il sistema non avrà bisogno di catene. Ci penseremo noi a indossarle da soli.