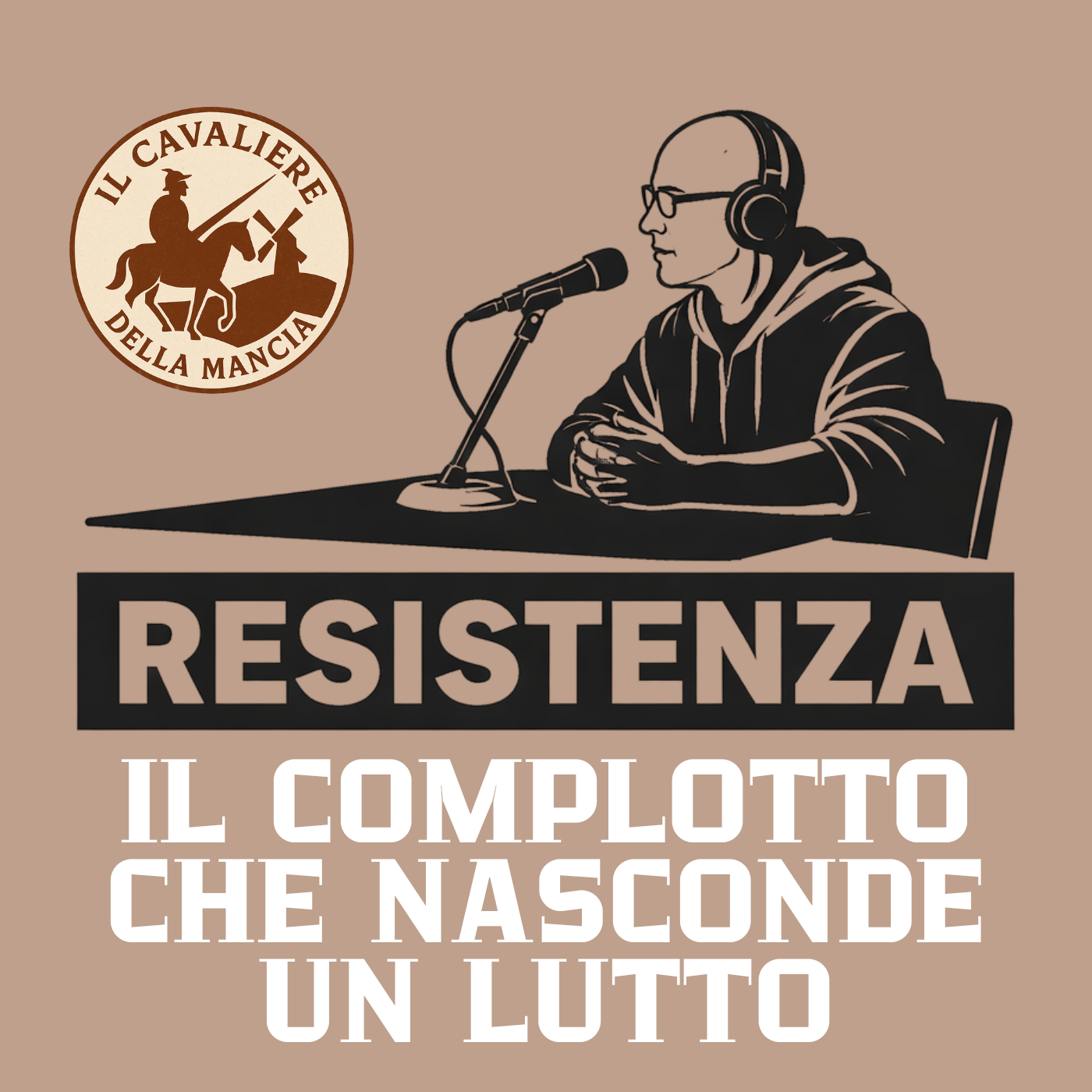Immaginate un Paese dove un tribunale assolve tutti gli imputati di un caso che ha infiammato le piazze, i talk show, i meme di Facebook, e che ha dato linfa alle peggiori campagne elettorali degli ultimi anni.
Immaginate che questo Paese, all'indomani della sentenza, invece di tirare un sospiro di sollievo per aver chiuso una delle vicende più tossiche e strumentalizzate della sua storia recente, si ritrovi ancora più diviso, confuso, e soprattutto... incapace di fare i conti con la realtà.
Bibbiano non è finito con l'assoluzione. E non finirà nemmeno quando l'ultima replica di chi urla al "complotto dei giudici" smetterà di circolare su TikTok. Perché Bibbiano, come simbolo, non è mai stato reale. Ma come problema sistemico, sì. E lo è ancora.
Un'amica e collega di studi (sto finendo Psicologia) mi ha detto una cosa che mi ha colpito: "Io non riesco a rallegrarmi per l'assoluzione. Non credo che fosse tutto pulito. Prima di pensare alle vite distrutte dei professionisti, penso ai minori. E alle loro famiglie."
Frase scomoda. Incontournable. Una di quelle che ti costringe a fermarti. E a non usare il processo come un pretesto per semplificare. Perché in Italia o si sta coi bambini torturati o coi professionisti vittime di linciaggio. O sei pro-servizi sociali, o sei No-Servizi. E invece, forse, siamo tutti – o dovremmo essere – molto più a disagio di così.
Sgomberiamo subito il campo dalle fandonie. Non è esistito nessun "sistema Bibbiano" inteso come rete organizzata di assistenti sociali, psicologi e giudici che rubavano bambini per darli in adozione a coppie omosessuali in cambio di soldi. Quella era, e resta, fuffa tossica, alimentata da una destra in cerca di facili bersagli e da una stampa compiacente o incompetente.
La verità processuale è chiara: undici imputati assolti su tutta la linea per le accuse più gravi. Nessuna rete, nessuna tratta, nessun piano segreto.
Ma – e qui sta il punto – non è che "non è successo nulla". Alcuni comportamenti deontologicamente scorretti ci sono stati. Documenti falsificati, test proiettivi interpretati in modo forzato, pressioni indebite su minori vulnerabili. Non tutto è reato. Ma tutto questo, per chi lavora o studia psicologia, è un campanello d'allarme enorme.
Il sistema di tutela del minore in Italia è fragile. Lo sanno gli avvocati, lo sanno gli operatori, lo sanno soprattutto i genitori che si trovano dentro una procedura di allontanamento. Lo sanno i bambini. Lo sappiamo anche noi studenti di psicologia, quando ci viene raccontato come funziona l'affido, chi decide, chi valuta, chi monitora. Troppo spesso, quella rete che dovrebbe essere di protezione diventa gabbia. O peggio, muro.
Una rete che, come diceva la mia collega, "troppo spesso è disumana e poco rispettosa del minore". Non sempre. Ma troppo spesso. E questo non è un problema giudiziario: è un problema etico, culturale, formativo. È un problema di selezione, di formazione, di supervisione. È un problema che non si risolve con una sentenza, ma che si incista quando ci si accontenta di dire: "Allora tutto a posto".
In questa storia, ci sono due bugie speculari:
La prima: che ci fosse una tratta organizzata di bambini. È stato smentito, e chi ancora lo ripete mente sapendo di mentire.
La seconda: che tutto fosse regolare, e che si tratti solo di professionisti incompresi. Anche questa è una finzione. Perché un sistema può produrre storture anche senza reati. Può fallire nel giudizio, nella prassi, nella vigilanza.
Quando salta un filtro – quello dell'etica professionale, della supervisione clinica, dell'umiltà epistemologica – può succedere il disastro. Un disastro silenzioso, fatto di bambini allontanati troppo in fretta, di famiglie che non capiscono perché, di giudici minorili che si fidano ciecamente delle relazioni degli assistenti sociali. Di strumenti psicologici usati in modo meccanico, quando non ideologico. Bibbiano è diventato, nella narrazione pubblica, un campo di battaglia. I bambini usati come proiettili politici. Le madri come scudi umani. Gli psicologi come burattinai o martiri, a seconda della narrazione.
Tutto sbagliato. Tutto falso.
I bambini coinvolti sono stati esposti, spiattellati, brutalizzati da chi diceva di volerli difendere. Le loro famiglie usate per fare titoli, indignazione, likes. Chi si è preoccupato davvero di loro? Chi li ha ascoltati dopo? Chi ha garantito loro protezione reale, non solo simbolica?
Ora che il clamore si è abbassato, qualcuno dovrebbe parlare di cosa ha funzionato male. Di come si selezionano e si formano psicologi e assistenti sociali. Di come si supervisionano. Di come si tutelano i diritti dei minori, ma anche dei genitori. Di quanto siano lenti, rigidi e burocratici i meccanismi di affido e reintegro. Di come evitare che l'ideologia – qualunque ideologia – infetti la prassi clinica e sociale. Chi si prende cura di chi si prende cura? Chi valuta i valutatori? Perché un assistente sociale in burnout, o un giovane psicologo entusiasta ma ideologico, possono fare danni devastanti.
Non è una vittoria per nessuno. Non per i politici che hanno fomentato l'odio, né per quelli che hanno taciuto. Non per gli psicologi, che non dovrebbero festeggiare un'assoluzione come se fosse un 6 politico. Non per i minori, che restano le vere vittime di tutto questo – non solo nei casi patologici, ma anche nel quotidiano grigio della disattenzione sistemica.
Serve un nuovo patto tra cittadini, servizi, professionisti e istituzioni. Un patto che metta al centro la complessità, non la propaganda. Che preveda trasparenza, ascolto, valutazioni plurime. Che affianchi ogni operatore a una rete di vigilanza, formazione, debriefing. Che eviti la solitudine della decisione. E che metta al centro, davvero, i diritti dei minori. Tutti. Compreso quello di non essere usati come simboli o martiri.
Bibbiano non era quello che ci hanno raccontato. Ma era – ed è – un sintomo. Di un sistema che troppo spesso funziona per inerzia. Di una cultura che preferisce lo scandalo alla riforma. Di professionisti che vengono formati male e lasciati soli. Di minori che diventano ostaggi, anche senza volerlo.
L'assoluzione non è la fine. È, semmai, l'inizio di un'altra conversazione. Più onesta. Più scomoda. Più utile. Parlarne non è negare il dolore.
Parlarne è il primo passo per non ripeterlo.
"Se sei un student di psicologia, se lavori nei servizi, se hai conosciuto da vicino la macchina dell'affido, questo non è il momento di difendere la categoria: è il momento di guardarsi allo specchio. Chiediamoci dove abbiamo fallito. Dove possiamo fare meglio. E, soprattutto, con chi. Perché se non ricominciamo dai minori – non dai simboli, non dai talk show – allora non stiamo facendo né psicologia, né giustizia. Solo rumore."