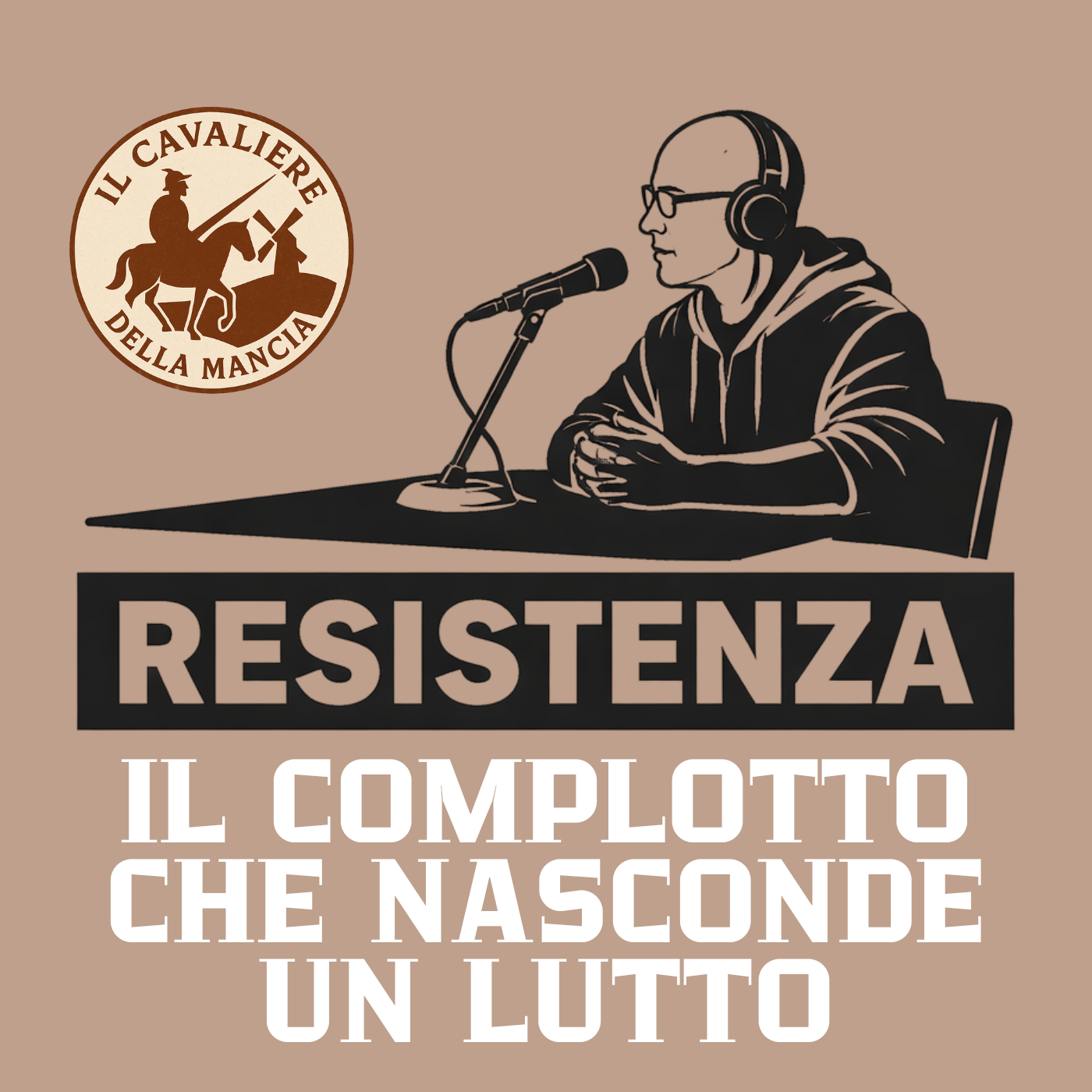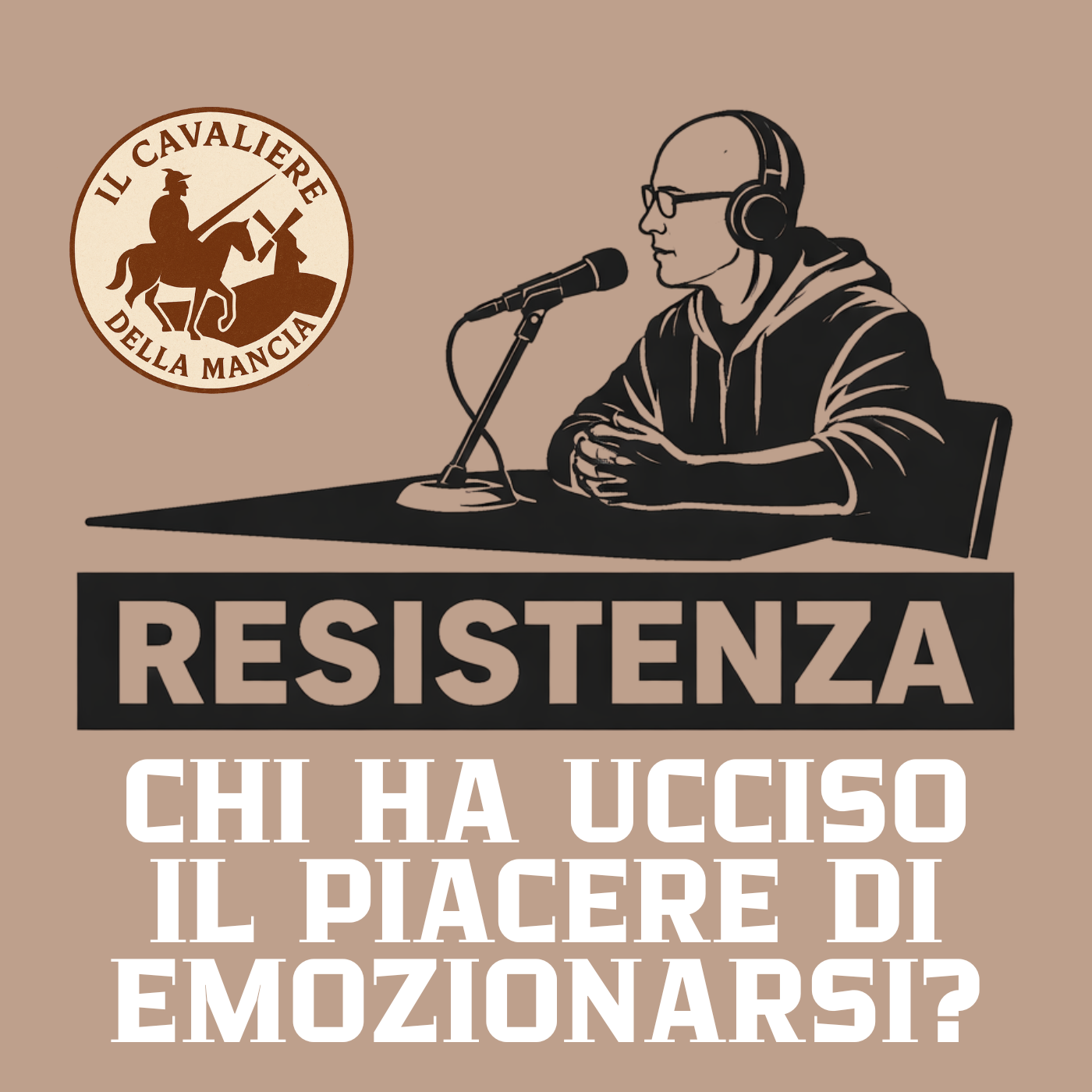Margherita Hack non cercava Dio, cercava coerenza.
Quando diceva "non ho bisogno di una religione per essere una brava persona", non stava dichiarando guerra alla fede. Stava ricordando, con la disarmante semplicità dei veri scienziati, che la bontà non è un dogma, ma una scelta quotidiana.
In un Paese dove la morale si confonde spesso con il catechismo, la sua frase suonava come una bestemmia gentile. Eppure conteneva un'evidenza che molti fingono di non vedere: per comportarsi bene non serve credere in un dio, basta credere nella responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri.
Hack non era un'atea rabbiosa, come qualcuno la dipingeva. Era una donna libera. La sua spiritualità non guardava il cielo, ma le stelle — e c'è una differenza enorme. Il cielo divide, le stelle uniscono. Il cielo pretende fede, le stelle chiedono solo di essere osservate.
Da giovane, quando scoprì l'astrofisica, disse che guardare l'universo le dava una forma di pace che nessuna preghiera le aveva mai dato: "sentirsi parte del tutto senza sentirsi al centro di nulla".
Ecco, in quella frase c'è già la chiave di tutto. Non l'arroganza di sostituirsi a Dio, ma l'umiltà di riconoscersi parte di qualcosa di infinitamente più grande — e di accettare che questo basti.
La religione, nel corso dei secoli, ha costruito il suo potere sull'idea che l'uomo sia moralmente incapace senza una guida superiore.
"Se Dio non esiste, tutto è permesso", scrive Dostoevskij, e i teologi l'hanno preso alla lettera. Ma forse aveva torto. Forse è vero il contrario: solo se Dio non esiste, possiamo essere davvero liberi di scegliere il bene.
Perché un atto è morale solo se non nasce dal timore o dalla speranza di un premio. Se ami il prossimo per guadagnarti il paradiso, non lo ami: lo baratti. Se rispetti la vita solo perché temi l'inferno, non sei buono, sei prudente.
Già Kant lo aveva intuito: la legge morale non è un ordine imposto dall'alto, ma una voce che abita dentro di noi. "Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona che in quella di ogni altro, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo."
Non serve un dio per capire questo. Serve solo empatia, coraggio, lucidità.
Eppure, la religione organizzata ha sempre diffidato dell'autonomia morale. Perché un uomo che ragiona con la propria testa è un uomo che non si controlla facilmente.
Così il "bene" è diventato obbedienza, e il "male" disobbedienza. E da secoli confondiamo la virtù con la sottomissione.
Giordano Bruno lo aveva detto a modo suo, prima di bruciare: "Non c'è religione più grande dell'amore per la verità."
E Darwin, due secoli dopo, lo confermò con la biologia: la cooperazione, non la competizione, è ciò che ha fatto sopravvivere la specie. L'etica è un vantaggio evolutivo, non un decreto divino.
Le neuroscienze oggi mostrano che il senso morale ha basi biologiche precise: aree del cervello che si attivano di fronte all'ingiustizia o alla sofferenza altrui. Non servono comandamenti scolpiti nella pietra, perché li abbiamo scritti nella carne.
Eppure, continuiamo a comportarci come se la bontà fosse un copyright del sacro.
Forse perché la paura — quella della morte, della punizione, del vuoto — è un collante potente.
Le religioni hanno imparato a trasformarla in linguaggio. "Fai il bene, o Dio ti giudicherà."
Ma la verità è che chi compie il bene per paura non è libero. È un suddito morale.
Hack, invece, proponeva l'esatto opposto: "Fai il bene perché puoi, perché è l'unica cosa sensata da fare in un universo indifferente."
In quella visione laica e luminosa c'è tutta la dignità dell'essere umano: agire senza garanzie, scegliere senza testimoni, creare senso nel silenzio cosmico.
Non c'è nulla di freddo in questo. È anzi una forma altissima di amore.
Amare senza aspettarsi un paradiso, perdonare senza timore dell'inferno, rispettare la vita solo perché è vita — non perché è promessa di qualcos'altro.
Chi vive così non ha bisogno di consolazioni ultraterrene: trova significato nell'esistere, non nel prolungarlo.
Margherita Hack non aveva paura della morte. O meglio: la temeva come tutti, ma non la considerava un fallimento. Diceva che l'universo esisteva da miliardi di anni prima di lei e continuerà dopo, e che non c'era niente di triste in questo: "La materia di cui sono fatta tornerà a essere parte del cosmo. Cosa posso volere di più?"
Era il contrario della disperazione: era gratitudine.
Forse è proprio questa la differenza tra il credente che spera e l'ateo che accetta. Il primo vuole sopravvivere, il secondo vuole comprendere.
Eppure, Hack non disprezzava la fede. Disprezzava il fanatismo. Diceva che ognuno è libero di credere in ciò che lo fa stare meglio, ma che nessuno ha il diritto di imporre la propria consolazione agli altri.
Era una scienziata, sì, ma soprattutto una donna etica. E la sua etica non veniva dai libri sacri, ma dal rispetto per la vita — quella delle persone, degli animali, della Terra.
Il suo ateismo non era un muro: era una porta aperta sul mistero.
Perché si può essere razionali senza essere aridi. Si può non credere in Dio e sentirsi comunque pieni di meraviglia.
Chi vi parla non ha meno paura di Hack. Ho paura di morire, di perdere chi amo, di sbagliare tutto. Ma non credo che serva una religione per dare un senso a questa paura.
Credo che la paura vada abitata, attraversata, capita — non venduta o mascherata da redenzione.
Se un Dio esiste, non si nasconde tra le nuvole: si manifesta ogni volta che scegliamo di non far del male, di ascoltare, di capire. Ogni volta che la coscienza ci dice: "Tu puoi essere migliore, anche se nessuno ti guarda."
Non è ateismo, è responsabilità.
Un uomo morale senza Dio è più libero, ma anche più esposto. Non ha scuse, non ha alibi, non può dire "così voleva il Signore". Deve guardare in faccia le conseguenze delle proprie azioni.
Forse è per questo che la libertà fa paura: perché ci obbliga a pensare, e a scegliere.
Ma è solo da quella paura che nasce l'etica autentica — non quella dell'obbedienza, ma quella della coerenza.
Ecco perché la frase di Hack è più che un motto. È un test di civiltà.
"Non ho bisogno di una religione per essere una brava persona" significa: non delego la mia coscienza.
Significa che l'amore, la solidarietà, il rispetto non hanno bisogno di sacramenti, ma di intenzioni.
Significa che la vita è sacra anche senza cielo.
E che la bontà, quella vera, non ha paura del buio.