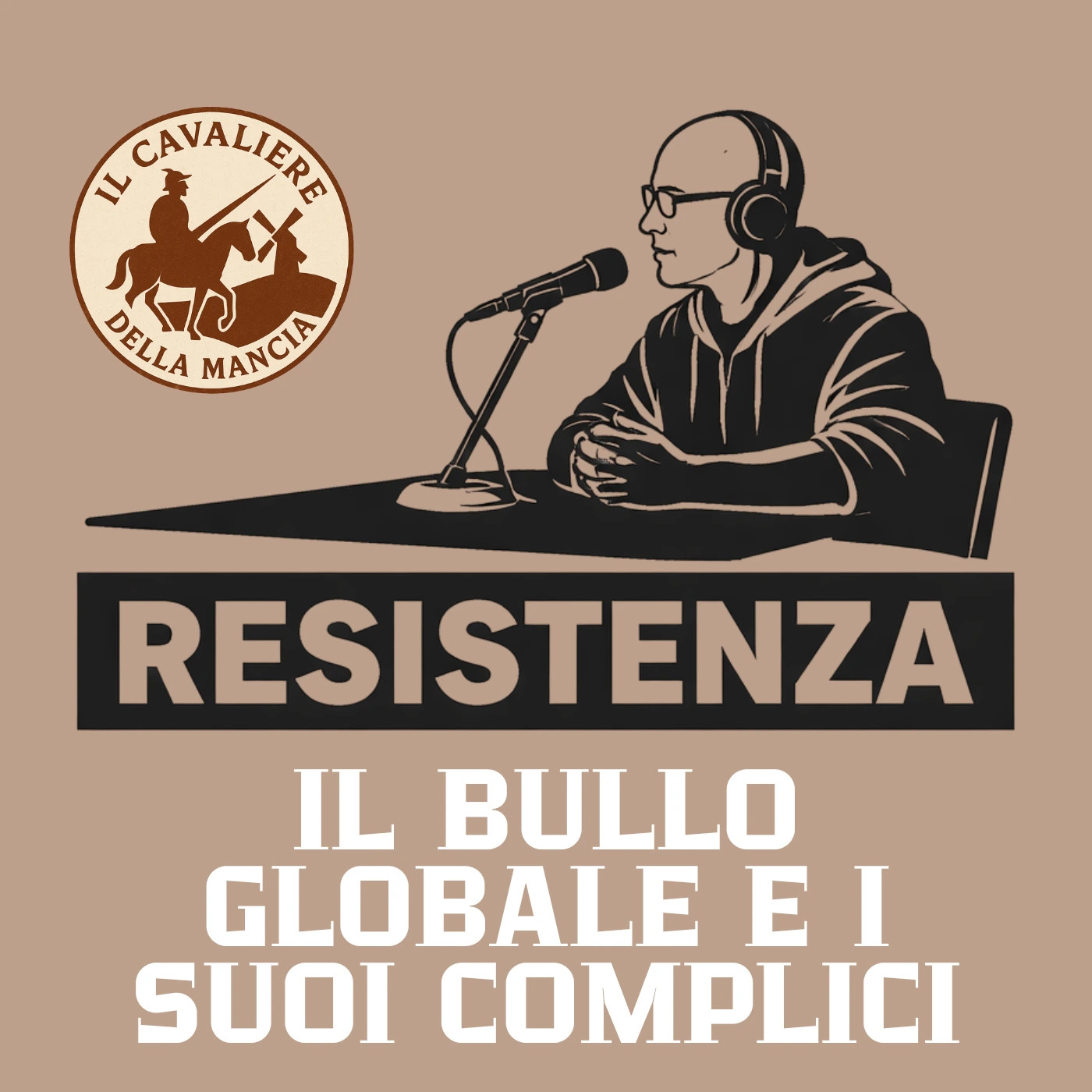Lo diciamo tutti, no? Quando la tua giornata è un delirio, quando qualcosa va storto, quando il tuo cane scappa con il pacco di pasta e il bambino gioca a fare l'archeologo con le tue scarpe nuove. È il termine che usiamo quando tutto è un casino, una confusione totale. Un "ambaradan" lo trovate anche nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle nostre vite. Ed è una parola che suona quasi simpatica, se ci pensi: una di quelle parole che, come una barzelletta, puoi usare senza pensarci troppo, senza chiederti cosa significhi davvero.
Ma oggi, lascia che ti faccia un'osservazione un po' meno comica. O forse comica, ma di quella risata amara che arriva quando realizzi che certe parole, nei decenni, hanno coperto delle tragedie.
Perché se oggi "ambaradan" significa disordine, caos, una specie di confusione infernale, c'è un'altra storia dietro questa parola che, invece di farci ridere, ci dovrebbe far tremare.
Siamo nel 1936, l'Italia fascista invade l'Etiopia con l'intento di creare il suo "Impero". Mussolini, il Duce che voleva andare alla conquista dell'Africa, mandò i suoi soldati a macellare, bombardare e bruciare tutto ciò che incontravano. Perché l'obiettivo era chiaro: imporre una supremazia razziale, annientando chi non si piegava all'idea di un "impero" fascista.
Ma la storia di cui voglio parlarti inizia sull'Amba Aradam, una montagna che avrebbe dovuto essere un rifugio, una protezione naturale per le forze etiopi che cercavano di resistere alla furia italiana. E qui, proprio su questa montagna, l'Italia ha scritto una delle pagine più oscure del suo passato coloniale.
Gli etiopi erano asserragliati tra le rocce, rifugiati nelle grotte, pronti a difendersi come potevano. E cosa fa il nostro esercito? Non combatte come un esercito normale. Non si limita a usare armi convenzionali. No, decide di fare qualcosa di poco umano, qualcosa che ricorda più un incubo che una battaglia. Il nostro esercito lanciò bombardamenti aerei con napalm, gas tossici, e lanciò gas asfissianti nelle grotte dove i soldati etiopi si nascondevano.
Il napalm bruciava vivo chiunque avesse avuto la sventura di trovarsi sulla sua traiettoria. L'odore della carne bruciata si mescolava al fumo delle terre incendiate. Ma la cosa peggiore, l'orrore vero, fu il modo in cui l'esercito italiano li murò vivi, chiudendo l'entrata delle grotte con dinamite, impedendo a chiunque di fuggire, di respirare. Gas, fuoco, morte. Un genocidio dimenticato, ridotto a una parola buffa, che oggi ci fa ridere mentre ci dimentichiamo che sotto quella risata ci sta una delle atrocità più gravi commesse dal nostro Paese.
Non era solo l'Amba Aradam. La guerra d'Etiopia fu una guerra chimica. Gli italiani, nella loro avanzata, non si fermarono nemmeno davanti alle leggi internazionali. L'utilizzo di armi chimiche, in quel periodo, era vietato, ma i fascisti decisero che il progresso e il "destino della razza" giustificavano ogni mezzo. Bombardamenti su civili, gas che veniva usato per asfissiare interi villaggi, e i famosi lanciafiamme che incendiavano tutto. Anche i pozzi d'acqua furono avvelenati. Se pensi che quella guerra fosse una "conquista civile", ti sbagli. Era un'esecuzione sistematica.
Gli ordini di Badoglio (il generale che, dopo aver massacrato i soldati etiopi, se ne sarebbe andato tranquillo per tornare alla sua carriera politica) erano chiari: nessuna pietà. E nessuna pietà fu mostrata: donne, bambini, anziani, combattenti disarmati. Tutti sterminati in nome di un'ideologia che giustificava ogni crimine. L'Italia, quella che oggi sembra una nazione pacifica, si fece largo nel continente africano con un fiume di sangue.
E qui, arriva la parte più insidiosa, quella che davvero fa male: il silenzio.
Non c'è stato un processo. Non c'è stato un tribunale per chiedere conto delle atrocità commesse in Etiopia. La memoria collettiva si è sistematicamente cancellata o trasformata in qualcosa di più comodo. Cosa è rimasto? La parola "Ambaradan", che oggi usiamo per fare ironia, come se fosse solo un sinonimo di "confusione".
Abbiamo rimosso tutto: le vittime, l'orrore, la sofferenza. Abbiamo ridotto una tragedia a una battuta. E così, mentre oggi si parla di fascismo come un'idea "da discutere", quella parola, quel massacro, restano lì, nei meandri dimenticati della storia. La nostra storia.
E così, ogni volta che ti capita di dire "che ambaradan!" con quel sorriso sornione, chiediti:
Cosa stai davvero evocando?
Perché ogni parola che usiamo ha un peso. Ogni termine che ripetiamo nella nostra lingua porta con sé una storia, una memoria. E non è un caso che un termine che oggi definisce la confusione di una giornata storta derivi proprio da un atto di violenza brutale, da un genocidio. La storia non è un'opinione. È una scelta.
Se ridiamo su una parola che porta con sé il ricordo di chi è stato bruciato vivo, di chi ha visto le proprie famiglie sterminate, di chi ha sofferto in modo indicibile… siamo davvero dalla parte giusta?
L'Amba Aradam non è solo una montagna. È un simbolo di una memoria sepolta, di un genocidio che non ci siamo mai veramente presi la briga di confrontare. Non possiamo, non dobbiamo ridurre quelle vittime a un ambaradan, perché questo è un modo per ucciderle ancora una volta: nel nostro pensiero, nella nostra cultura, nella nostra collettività. È un altro atto di violenza.
"Che ambaradan", certo. Ma per qualcuno, quella parola significa la fine di tutto.